Decreti legge: il vortice della legislazione d’urgenza
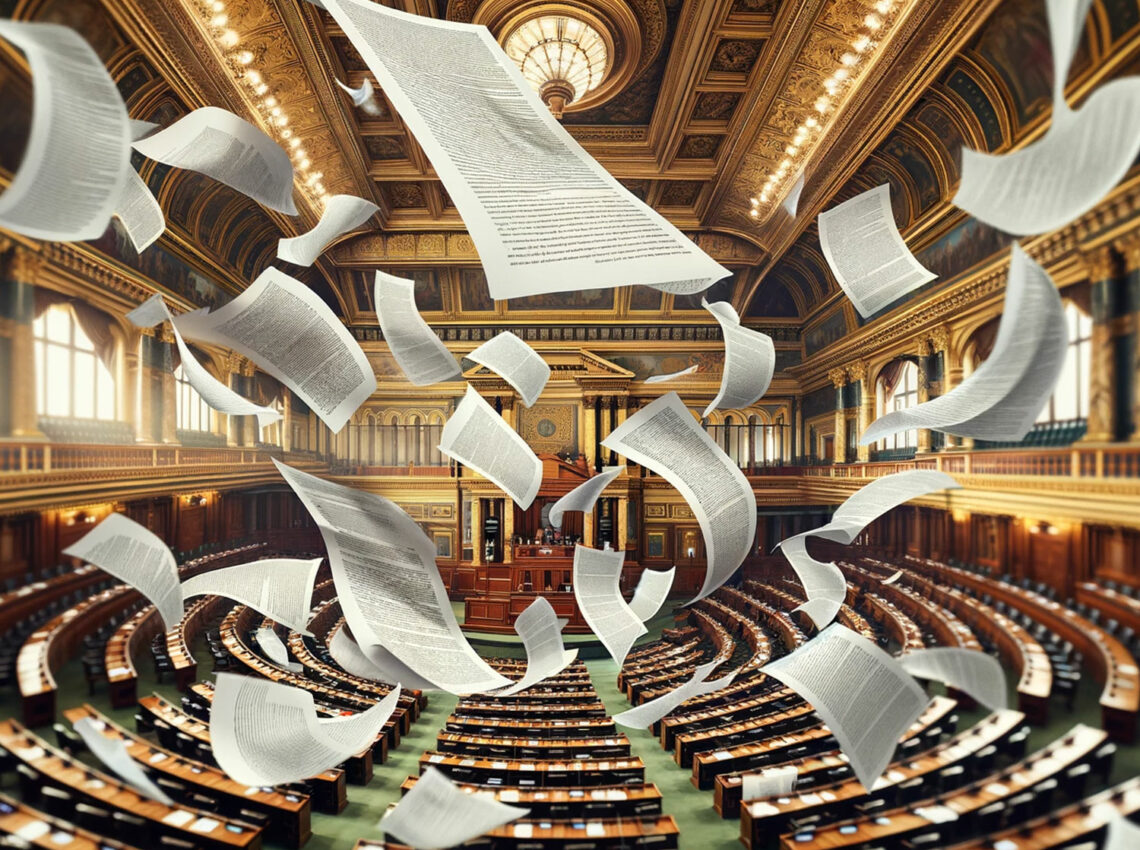
Una volta c’era la “navetta”, che traghettava le leggi dalla Camera al Senato e viceversa, in un continuo andirivieni: con gli anni, questa prassi si è bloccata a colpi di decretazione d’urgenza e questioni di fiducia poste dai Governi, indipendentemente dal colore politico o dalla propria natura.
L’italico bicameralismo perfetto ha ceduto il passo al monocameralismo di fatto, in quanto un ramo del Parlamento (numeri alla mano, sempre più marginale e irrilevante) esamina e modifica il testo, l’altro si limita a “bollinare”, senza toccare palla: una tendenza che non può essere ignorata nel momento in cui si affronterà il tema delle riforme istituzionali che l’Esecutivo intende portare avanti.
Il ricorso alla decretazione d’urgenza (i casi «straordinari» sembrano da molto tempo essersi trasformati in «ordinari») è giustificato nella misura in cui sia necessario affrontare questioni indifferibili e urgenti: negli ultimi anni infatti spesso sono stati pubblicati decreti legge per diverse emergenze, dalla siccità agli incendi, dai terremoti alle frane e alle alluvioni. Ma certamente l’emergenza pandemica prima e l’esplosione della guerra in Ucraina successivamente hanno influito in maniera significativa sul ricorso a questo strumento.
Come ha osservato in una recente intervista l’ex ministro della Giustizia, Marta Cartabia,
durante le situazioni di emergenza, le istituzioni non solo hanno «il diritto e il potere, ma anche il preciso ed indeclinabile dovere di provvedere», come osservava la Corte Costituzionale già nel 1982, a tutela della vita, dell’incolumità, della sicurezza delle persone e della società quando un pericolo le minacci, che sia la pandemia, una catastrofe naturale, una grave crisi economica, il terrorismo, gli attacchi della mafia, e altro ancora.
Va rilevato che spesso in passato gli esecutivi hanno fatto ampio ricorso alla decretazione d’urgenza non solo per intervenire nei casi suddetti, ma anche per dare una più rapida attuazione al programma di governo. Una consuetudine questa che, se accoppiata con il frequente ricorso alla questione di fiducia, riduce in maniera significativa le prerogative del parlamento.
Nell’ambito della Relazione sull’attività legislativa e attuativa del governo Draghi nel 2021, viene messo in evidenza come “Nel fronteggiare la pandemia da coronavirus […] si è dovuto ricorrere di frequente alla decretazione d’urgenza, attesa la valutata opportunità […] di innalzare in tale ambito il rango della fonte di disciplina. Al contempo, l’urgenza di assicurare prima attuazione al Pnrr […] ha reso improrogabili numerose disposizioni legislative, spesso emanate sulla base di oggettivi presupposti di eccezionalità ed urgenza”.
L’ eccessivo ricorso ai decreti legge comporta anche delle criticità di natura “tecnica”: la proliferazione dei decreti legge infatti ha l’effetto di saturare l’agenda delle Camere, che non solo ha spazi di manovra ridotti per occuparsi di altri temi, ma anche poco tempo per entrare nel merito delle misure adottate con il decreto. Data la necessità di convertire i decreti prima della loro scadenza, spesso il Parlamento quindi si vede costretto a prendere atto delle decisioni già prese a palazzo Chigi.
Come ben si può capire, si è venuto così facendo ad innescare un inesauribile ed inarrestabile circolo vizioso.
Il decreto-legge, mosso dall’esigenza di anticipare gli effetti del provvedimento senza attendere i tempi del procedimento parlamentare, ha provocato il rafforzamento della sua causa, cioè ha fatto ulteriormente allungare i tempi medi dell’iter. Ciò fa inesorabilmente allungare i tempi del processo legislativo, andando di conseguenza a rendere quasi inevitabile adottare i provvedimenti “urgenti” con decreto-legge e viceversa. Perciò l’aumento della decretazione d’urgenza altro non realizza che far esplodere a dismisura l’uso della stessa.
Se il decreto-legge viene utilizzato per assicurare l’immediata entrata in vigore di un qualsivoglia provvedimento legislativo che è di cruciale importanza e interesse per l’esecutivo, non si può di certo pensare che venga meno però il potere del legislatore di discuterlo ed emendarlo. Ma se la decretazione d’urgenza viene adottata per varare complesse discipline, per le quali l’ordinario iter legislativo sarebbe troppo dispersivo, è altamente improbabile che il termine massimo ed imperativo di sessante giorni sia sufficiente all’esame parlamentare.
Ancora una volta, l’incremento del ricorso alla decretazione d’urgenza, genera l’incremento della decretazione d’urgenza; più decreti si emanano, più sono i decreti che rischiano di decadere, perché meno tempo ha il Parlamento per discuterli e approvarli; più sono i decreti che decadono, più sono i decreti che devono essere emanati per mantenere gli effetti, e così via.
Il Presidente della Repubblica ne ha più volte stigmatizzato l’abuso e la Corte Costituzionale ha corretto le distorsioni più gravi, vietando la reiterazione e arginando la disomogeneità.
La Consulta, con la celebre sentenza n. 360 del 1996, ha dichiarato tale prassi in contrasto con la Costituzione, sulla base di cinque argomentazioni: in primo luogo, poiché altera la natura provvisoria del decreto – legge, espressamente stabilita dalla Costituzione; in secondo luogo, poiché toglie valore al carattere straordinario dei requisiti di necessità e urgenza; in terzo luogo, poiché attenua la sanzione, ricollegata alla mancata conversione entro il sessantesimo giorno, della decadenza con perdita di efficacia ex tunc; in quarto luogo, poiché altera i caratteri della forma di governo, il cui assetto è strettamente connesso con quello del sistema delle fonti, vanificando l’attribuzione al Parlamento della funzione legislativa ordinaria; in ultimo luogo, poiché finisce per intaccare il valore della certezza del diritto, per l’impossibilità di prevedere la durata nel tempo delle norme reiterate e l’esito finale del processo di conversione.
Non sembra realistico immaginare che un Governo, di qualunque colore, riesca a rinunciare, oltre una certa misura, alla corsia preferenziale del decreto legge, che, oltre ad offrire tempi di esame certi, ha l’incredibile vantaggio dell’entrata in vigore immediata (a differenza dei disegni di legge collegati alla manovra economica), oltre a quello non trascurabile di poter porre facilmente la questione di fiducia.
I ritmi registrati dai governi che si sono avvicendati negli ultimi 15 anni sono sensibilmente più bassi rispetto a quelli dell’attuale esecutivo. In sostanza, quello di Meloni è un vero e proprio record, secondo i numeri messi in fila da Openpolis. Mario Draghi approvò in media 3,2 decreti al mese, il Conte II 3,18. E ancora: il governo guidato da Enrico Letta si attesta a quota 2,8, quello di Mario Monti a 2,4; mentre Berlusconi, Renzi, Gentiloni e il Governo giallo-verde si collocano tutti sotto la media dei 2 decreti ogni trenta giorni.
I dati elaborati restituiscono la fotografia di un Parlamento che nella maggior parte dei casi finisce per svolgere un ruolo subalterno all’esecutivo, ormai vero protagonista dell’azione legislativa.
Come se non bastasse la prassi ormai vuole che all’interno di un solo decreto vengano infilate altre norme, molto spesso completamente estranee alla sua finalità: si tratta dei cosiddetti ‘decreti omnibus’.
Tale situazione patologica deve essere riportata a normalità, restituendo al Parlamento la sua centralità come sede aperta di confronto, soprattutto per i provvedimenti di ampio respiro, prendendo l’iniziativa o attraverso la legge ordinaria o, più, realisticamente, attraverso la legislazione delegata, chiamando le Camere a fissare i principi e i criteri che poi il Governo deve seguire in fase di attuazione.
L’attuale inarrestabile dinamica potrebbe essere corretta, con una razionalizzazione dei lavori parlamentari. «Con due Camere dotate degli stessi poteri, l’efficienza dei lavori può essere anche superiore» ha rilevato Andrea Pertici, docente di diritto costituzionale all’Università di Pisa. «Normalmente è la Camera chiamata a intervenire per prima a compiere tutta l’istruttoria relativa alla deliberazione da assumere, cosicchè, con due Camere, se ne possono svolgere due contemporaneamente. Per esempio, mentre il Senato si occupa di una legge , la Camera può dedicarsi a un’altra, per poi scambiarsi testi». La conseguenza? «Se ben confezionati e condivisi possono essere approvati». In altri casi, osserva sempre Pertici, «la seconda Camera può essere uno strumento utile a correggere errori tecnici o posizioni politiche non consolidate. Solo in casi rari sarà utilizzata quale meccanismo meramente dilatorio».
Il problema della proliferazione dei decreti legge va affrontato alla radice, con una riforma che aggredisca le cause di questa prassi. Serve una corsia preferenziale in parlamento per i disegni di legge approvati dall’esecutivo, altrimenti si finisce sempre per ricorrere ai decreti. I governi sempre più spesso si trovano di fronte ad una serie di emergenza che cercano di affrontare attraverso la decretazione. In altri Paesi avviene la stessa cosa, ma con i disegni di legge, perché per la loro approvazione ci sono tempi certi, che da noi non esistono.
In questa prospettiva un ruolo fondamentale assumano tutti gli strumenti in grado di restituire al Parlamento centralità nel processo decisionale.
A tal fine, è indispensabile ampliare tutti gli strumenti di approfondimento conoscitivo, anche nei tempi stretti previsti per la conversione dei decreti legge. Il che, in altri termini, si dovrebbe tradurre nella valorizzazione del ruolo che potrebbero avere le commissioni in sede consultiva, così come anche altre forme di consultazione che hanno già mostrato un impatto piuttosto positivo.
Non dimentichiamo che il nostro sistema è stato improntato ad un bicameralismo paritario che, come precedentemente evidenziato, si è trasformato di fatto in un “monocameralismo alternato”: ciò accade in modo particolare durante l’esame della più importante legge dello Stato, la legge di Bilancio.
Rispetto alla passata legislatura sono intervenuti due fattori nuovi: il ritorno di un Governo decisamente politico e la prima applicazione della riforma costituzionale che ha drasticamente ridimensionato il numero dei parlamentari (a cui non sono peraltro seguite le ulteriori riforme che avrebbero dato un senso compiuto all’operazione, come una nuova legge elettorale o l’adeguamento degli stessi regolamenti parlamentari rimasto incompleto).
Camere molto più snelle e un esecutivo dotato di una maggioranza potenzialmente coesa rappresentano condizioni teoricamente a netto vantaggio della valorizzazione del procedimento legislativo.
Questa discontinuità sicuramente potrebbe anche costituire il miglior viatico per riprendere il filo interrotto delle riforme istituzionali e parlamentari, affrontando in termini più strutturali il problema della patologia sopra descritta nei rapporti tra Governo e Parlamento.






