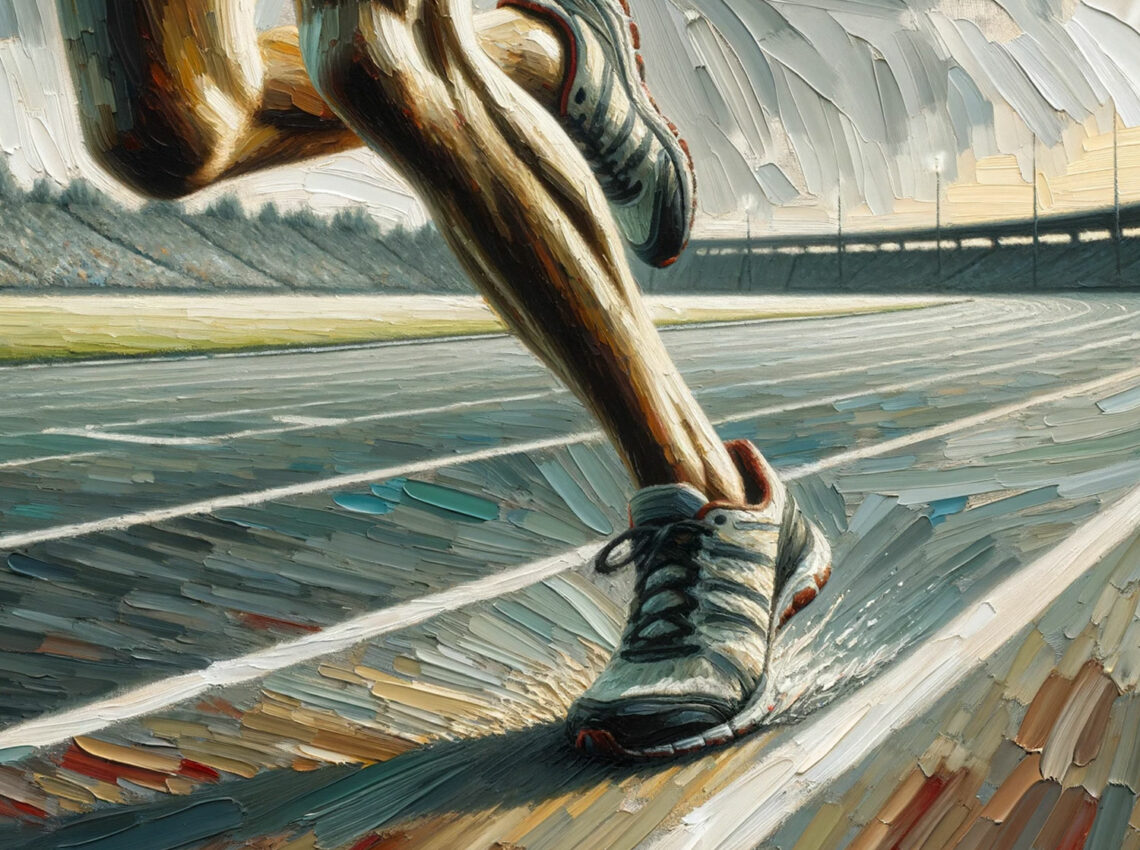Blockchainwashing: quando la tecnologia a registri distribuiti è (in)utile.

Negli ultimi anni sono innumerevoli i progetti blockchain rilanciati dalla stampa in termini sensazionalistici di cui poi si perde completamente traccia. Dall’olio EVO alla mozzarella di bufala, dalla cartolarizzazione di beni immobili al rilascio di attestai di merito, dalla riscossione del diritto d’autore alla gestione delle comunità energetiche. Eppure, al di fuori di poche (anzi pochissime) applicazioni nel settore fintech, la blockchain non ha affatto rivoluzionato il mercato consumer come prometteva, né si vedono all’orizzonte diverse prospettive.
L’entusiasmo del pubblico e degli investitori si è pian piano affievolito, un po’ per gli scarsi risultati effettivamente conseguiti, un po’ per lo scoppio della bolla NFT concomitante con alcuni scandali d’oltre oceano cui è seguito un periodo di diffusa sfiducia noto, in termini giornalistici, come crypto-winter.
Oggi, con i fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale e per effetto del rialzo del valore dei bitcoin, le soluzioni blockchain stanno riguadagnando un certo allure e bisogna più che mai chiarire con fermezza cosa può, e soprattutto cosa non può, fare questa tecnologia per evitare un nuovo effetto “blockchainwashing” con conseguente dispersione di risorse pubbliche e private.
Cosa non fa la blockchain
Trattandosi della presunta caratteristica ancora oggi più sbandierata, va subito detto che la blockchain di per sé non certifica né autentica alcunché (tantomeno «notarizza», qualsiasi cosa ciò significhi).
L’attività di certificare e autenticare è operazione tipicamente rimessa ad un soggetto fiduciario (es.: pubblico ufficiale) che attribuisce status di verità ad una affermazione o attesta la paternità di un atto. Ebbene, in tali termini il mero caricamento di una informazione in blockchain non la rende per ciò solo corretta, né è utile a conoscerne la provenienza.
Altra proprietà erroneamente attribuita alla blockchain è quella di consentire il trasferimento di un qualsiasi asset previa sua «tokenizzazione»: ovvero la pretesa di conseguire un determinato effetto giuridico consistente nel trasferimento di un diritto di proprietà o di godimento su un bene con il mero trasferimento di un token nel quale tale diritto o bene sono descritti.
Una siffatta operazione, invero – ammesso che si adotti una soluzione tecnologica che effettivamente riesca a tokenizzare un bene fisico – non può prescindere dalle disposizioni civilistiche su eventuali vincoli di forma e procedura (si pensi alla compravendita immobiliare che necessita della forma scritta e dell’intervento di un notaio o alle regole in tema di titoli di credito), né può garantire in alcun modo che la sorte del bene fisico sia immediatamente e direttamente trasferita sul suo gemello digitale (il token).
Cosa fa la blockchain
La tecnologia a registri distribuiti, per l’appunto, distribuisce i registri. Distribuisce, cioè, la loro conservazione (storing) e il corretto caricamento e aggiornamento delle informazioni in essi scritte (validazione). Sono proprio la possibilità di condividere i registri e la capacità di eseguire in modo collaborativo le annotazioni i due elementi fondamentali che conferiscono alla blockchain quell’elemento “trustless” per cui è nota: la tipica funzione di soggetto fiduciario che provvede alla tenuta dei registri contabili e che si atteggia a garante della loro correttezza è sostituita dall’esecuzione di un protocollo informatico (distribuito) in forza del quale tutti controllano tutti e assumono decisioni (validazioni) secondo un democratico criterio maggioritario.
Pertanto, condizione necessaria per cui l’applicazione di una soluzione blockchain abbia senso è che il sistema sia configurato con una architettura distribuita; più in particolare, che lo storing e le validazioni siano eseguiti con la partecipazione più o meno paritetica (peer-to–peer) di numerosi “nodi” che, a loro volta, possano operare in effettiva autonomia e indipendenza.
La blockchain al di là del fintech
I progetti fintech (uno per tutti, il progetto «Spunta Banca DLT» promosso da ABI Lab) non hanno difficoltà a rispettare le caratteristiche indicate al paragrafo precedente (distribuzione dello storing e delle operazioni di validazione dei dati). In tali casi, infatti, i partecipanti hanno interessi contrapposti e devono riconciliare partite contabili tra loro e, quindi, fare semplici operazioni matematiche di somma e sottrazione annotando in DLT il risultato di compensazioni di debiti e crediti.
Assai diverse sono le esigenze dei partecipanti ad un progetto blockchain in settori non fintech (tipicamente per tracciabilità di filiera), ovvero laddove non si debbano riconciliare dati quantitativi – o almeno non solo –, ma si debbano per lo più riconciliare dati qualitativi: “certificare” in blockchain l’origine di un prodotto o il rispetto di qualche parametro ESG non può essere ricondotto con un semplice calcolo aritmetico alle categorie logiche di “vero” o “falso”, ma implica un calcolo algebrico in grado di conferire a dichiarazioni espresse in linguaggio naturale (in ordine a soggetti, luoghi, circostanze, tempi, risorse, ecc.) un variabile grado di attendibilità.
In altri termini, un qualsiasi calcolatore può verificare la correttezza di una transazione valutaria confrontando gli importi in dare e avere. Ed è proprio ciò che accade per esempio nel network Bitcoin dove più nodi collegati e sincronizzati possono effettivamente verificare, in modo autonomo e indipendente, le transazioni proposte dagli utenti e validare solo quelle corrette.
Verificare invece da dove viene e come è fatto un prodotto è tutt’altra cosa. Validare, cioè, le dichiarazioni rese dagli operatori di filiera richiede una particolare cura nel design di protocolli di validazione che coinvolgono diverse fonti informative e siano in grado di rilevare livelli di incoerenza tra i dati tali da mettere in dubbio la loro correttezza e completezza.
In tale prospettiva, caricare informazioni in blockchain relative ad un asset fisico senza sottoporli ad un qualche protocollo di validazione algebrica non ha alcuna utilità in temini di accertamento della veridicità di tali informazioni. Né si possono considerare attendibili i dati in blockchain allorché, pur sottoposti ad una corretta validazione, siano tuttavia caricati da un unico soggetto che sostanzialmente agisce da nodo centralizzato per il data entry e le cui dichiarazioni, quindi, possono essere opportunisticamente rilasciate per superare i controlli di coerenza attivati con smart contract.
Conclusioni
Nell’ambito di un lavoro di ricerca svolto dall’Associazione Blockchain Italia, sono stati scrutinati decine di progetti blockchain non fintech. Alcuni sviluppati e commercializzati da multinazionali del food e colossi dell’informatica che hanno avuto un enorme eco mediatica. Per quanto è dato sapere, nessuno di tali progetti ha implementato le logiche distributive e di validazione descritte nei precedenti paragrafi e nessuno – prevedibilmente – ha in qualche modo inciso nel rapporto tra produttore e consumatore né ha contribuito al monitoraggio della catena del valore o al controllo di disciplinari tecnici di produzione, di compliance legale o standard di mercato.
Tuttavia, le potenzialità della blockchain sono enormi, e di effettiva utilità per il perseguimento di politiche di tutela del made in Italy, a patto di comprendere a fondo le logiche che la governano e di tenere in considerazione gli effetti giuridici del suo impiego, ma soprattutto a condizione che si voglia davvero adottare nuovi e più efficienti modelli di business che solo questa tecnologia può abilitare.