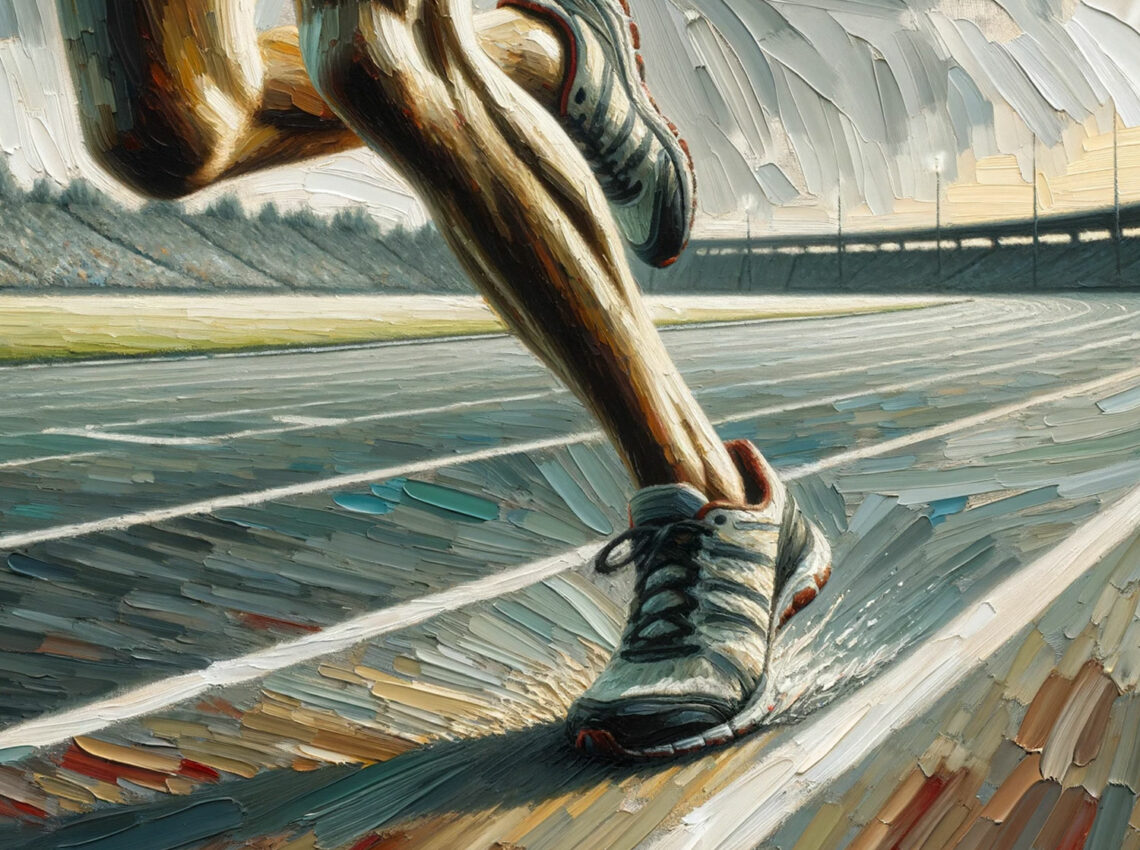G7: negoziamo la pace e poniamo in atto un piano industriale circolare e sostenibile

Il modo di vivere, produrre e consumare sul nostro pianeta non è più sostenibile, ne siamo coscienti, per questo abbiamo approcciato nuovi modelli come l’economia circolare, ma ora c’è qualcos’altro che ci preoccupa: la guerra. La nostra comunità è minacciata dall’inquinamento, dallo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, dalla siccità, dal cambiamento climatico e purtroppo anche da conflitti alle nostre porte. Le cause che muovono una nazione a dichiarare guerra ad un’altra possono essere i contrasti religiosi, etnici, la presa del potere politico, ma al primo posto troviamo il controllo delle risorse naturali come l’acqua, il petrolio, i minerali. Storicamente è sempre stato così, e in questo momento storico la connessione fra le guerre in atto e il nostro stile di vita, che perpetua il meccanismo di accumulo della ricchezza, ci porta ad effettuare alcune riflessioni. La transizione ecologica è una strategia da porre in atto per non continuare a sbagliare, a volte viene dipinta come un peso che graverà sui più bisognosi, ma in realtà è esattamente il contrario. Il viraggio verso un modello economico social ecologico è necessario per preservare la salute dei cittadini, dell’ecosistema e assicurare un futuro ai nostri figli. È il viraggio verso una società più rispettosa dell’altro, più inclusiva e giusta, verso l’eliminazione dei rifiuti e dello spreco di energia.
L’estrazione di risorse naturali e soprattutto delle risorse non rinnovabili, è notevolmente aumentata negli anni, si conta che negli ultimi 30 anni, la quantità di materiali estratti per alimentare il nostro modello economico di crescita ha superato il 60%. Un quinto di risorse naturali che vengono estratte sul pianeta, dopo la trasformazione in prodotti e dopo l’uso a fine vita diventano un rifiuto inutile, ed è per questo che negli ultimi anni si sta imponendo una nuova logica di consumo basata su efficienza, innovazione, prevenzione degli sprechi, riutilizzo e riciclaggio, in una sola parola dobbiamo passare da un’economia lineare ad una circolare. Nei sistemi di economia circolare i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e i rifiuti si riducono al minimo. Quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse restano all’interno del sistema economico, in modo da poter essere riutilizzate più volte a fini produttivi e creare così nuovo valore. Questo modello di sviluppo, anche se è alla ribalta nel dibattito mondiale da pochi anni ha radici lontane, risale alle intuizioni di molti economisti e studiosi del passato, tra i quai ricordiamo Nicholas Georgescu Roegen, Giorgio Nebbia e Barry Commoner, quest’ultimo autore del libro “The closing circle”. Era il 1971 e Commoner, biologo marino, ci esponeva la circolarità dei processi naturali, che si concludono e poi ricominciano, a differenza delle tecnologie produttive odierne che utilizzano in prevalenza processi lineari, il cui esito sono accumuli di rifiuti e di emissioni impattanti in atmosfera e disequilibri. Negli anni ’70 del secolo scorso l’ecologia iniziò ad affacciarsi come realtà di cui tener conto, e si affermò come elemento presente nel dibattito pubblico, portando all’attenzione del mondo accademico la connessione fra le leggi della termodinamica e il modello economico. Nel 1970 il Consiglio d’Europa proclamò l’Anno europeo della conservazione della natura, e due anni dopo le Nazioni unite annunciarono la prima grande conferenza mondiale sull’ambiente, così l’analisi delle problematiche mondiali iniziarono ad acquisire un approccio di tipo sistemico. Dalle intuizioni di Commoner è trascorso quasi mezzo secolo, e a che punto siamo? Il ritardo che abbiamo accumulato nell’avvio di un nuovo modello economico circolare, a basso contenuto di carbonio è evidente. “La natura non conosce rifiuti” affermava lo studioso, “le trasformazioni naturali sono alimentate dall’energia del sole, la materia rientra sempre nel ciclo e viene riutilizzata; le sostanze chimiche estratte dall’aria, dall’acqua e dal terreno ritornano in circolazione, ridiventando materie prime per altri cicli naturali; purtroppo, dinanzi alle trasformazioni umane, cariche di inquinamenti e attività sovversive, i cicli naturali si trasformano, e da chiusi si fanno aperti. I rifiuti aumentano a tal punto che la natura non riesce ad assimilarli tutti, conducendo il sistema al tracollo”. Se consideriamo le sue osservazioni, ci rendiamo conto che gli interventi volti a stabilire anche nei processi antropici la circolarità della natura, sono oggi più urgenti che mai.
Il capitale naturale è definito come l’intero stock di asset naturali, organismi viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche che contribuiscono a fornire beni e servizi di valore, diretto o indiretto per l’uomo e che sono necessari per la sopravvivenza dell’ambiente stesso da cui sono generati. L’inefficiente gestione del capitale naturale si verifica spesso, perché il suo pieno valore fin ora non si è riflesso nelle scelte politiche ed economiche. È evidente che l’ottimizzazione dell’economia circolare non può che avvenire attraverso la contabilità del capitale naturale, ossia calcolando la quantità di stock di risorse non rinnovabili e i flussi delle rinnovabili che fornendo servizi eco-sistemici sostengono la società, l’economia e la vita sul nostro pianeta. Soltanto attraverso una base di conoscenze, sviluppate effettuando una valutazione chiara del capitale naturale, quella che chiamo “contabilità ambientale”, sarà più facile valutare in modo ottimale i giusti ingredienti di opzioni di politiche per riuscire ad effettuare una vera transizione da un’economia brown-lineare ad una green e circolare.
In Italia sono nate molte piattaforme con l’obbiettivo di promuovere l’economia circolare favorendo l’integrazione delle iniziative della rete di imprese e diffondendo le eccellenze nazionali a partire dalle tradizioni e dalle tipicità nazionali e dai relativi modelli culturali, sociali ed imprenditoriali. Ho seguito personalmente molti gruppi di lavoro e piattaforme come l’ICESP, e ancora oggi mi confronto con tutti gli attori italiani che vogliono perseguire l’obiettivo di sviluppare una reale economia circolare. Fare rete, lavorare insieme, condividere buone pratiche, idee innovative e strategie è fondamentale perché non basta effettuare riforme e leggi, l’azione politica deve andare di pari passo con una formazione e informazione chiara su nuove tecnologie e metodi. Ai tavoli di lavoro devono esserci i policy maker, le imprese, gli esperti, le università, le associazioni e la società civile, per condividere esperienze, criticità e prospettive su dinamiche di ecodesign, greenwashing, progettazione e appalti pubblici sostenibili, marchi e certificazioni ambientali, limitazione degli sprechi alimentari, incentivi economici e fiscali, ricerca ed eco-innovazione. La partecipazione di tutti gli stakeholder, la condivisione e l’elaborazione di approcci integrati, è l’unico modo per spianare la strada alle politiche sostenibili e di resilienza dettate anche dal nostro PNRR.
Una via di salvezza, dunque, esiste ancora.
La necessità avvertita dalla comunità internazionale è quella di far nascere una filiera inversa, capace di sostenere le piccole e medie imprese, e non solo i produttori ma anche i trasformatori, le aziende di servizi. Per realizzare ciò, bisogna mettersi in gioco ed evitare che si continui ad avere una visione “a blocchi” , ad agire per “compartimenti stagni”. Se vogliamo chiudere il cerchio, raggiungere gli obbiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030 e mantenere il sistema produttivo italiano competitivo, dobbiamo porre in atto un cambio di paradigma capace di dare l’avvio ad una nuova politica industriale finalizzata alla sostenibilità in tutte le sue forme, con innovazioni di processo in grado di incrementare la competitività del prodotto e della manifattura italiana, ripensando il modo di consumare e fare impresa. A gran voce il sistema imprenditoriale Italino chiede da tempo un piano industriale, purtroppo ancora non pervenuto. Un piano che con consapevolezza deve utilizzare la transizione ecologica come un’opportunità per eco-innovare, creare posti di lavoro green, restare competitivi nel mercato globale. Ma non dobbiamo sottovalutare il fattore guerra.
Negoziare la pace oltre a salvare vite umane, offre l’opportunità di creare accordi che possono rispettare i bisogni delle parti e promuovere l’uso sostenibile delle risorse, evitando gli effetti devastanti come la distruzione di ecosistemi e il pericolo che venga meno la sicurezza alimentare. Il G7 il cui vertice si terra in Puglia a giugno, è un’occasione per porre l’attenzione sulla crisi ambientale, sulla guerra e sulla ripresa economica del nostro Paese, tre temi connessi fra loro che dunque devono essere trattati con lo stesso peso politico.