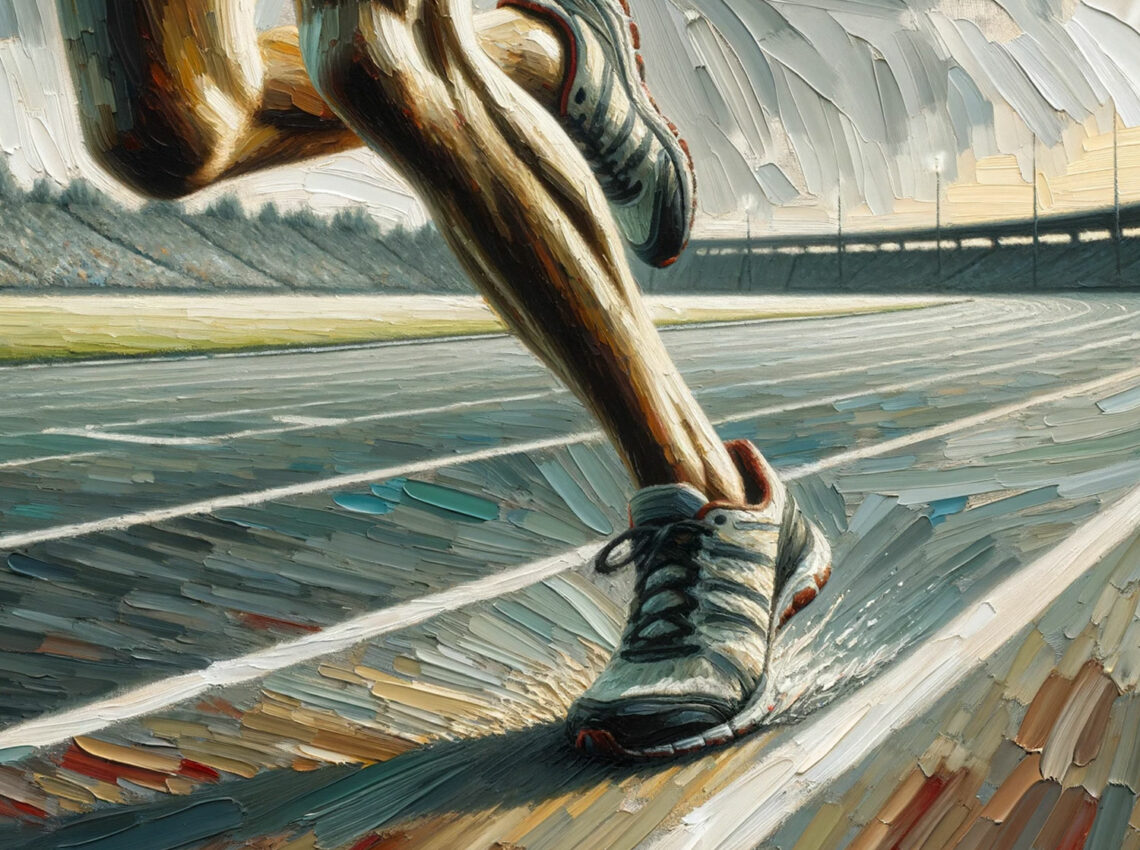Il caso Meta: se una multinazionale vuole controllare l’informazione politica è giusto intervenire per impedirlo

Ricorreva il 10 febbraio 2021 quando la multinazionale Meta (ex Facebook) comunicava per la prima volta una delle sue più allarmanti e decisamente opache novità: la scelta di iniziare a controllare, direttamente, la distribuzione dell’informazione politica, sociale e civica sulla sua piattaforma principale, Facebook. Un controllo esteso nel novembre del 2022 anche in Italia e basato su variabili ad oggi sconosciute, non condivise, che oggi si sostanzia nella manipolazione (occulta, cioè non notificata agli interessati) della visibilità di post, pagine e profili per tramite di un’alterazione della stessa nelle News Feed degli utenti (lo spazio dove rende più o meno visibile un post), che come da dati ed evidenze raccolte negli ultimi due anni può essere ridotta fino all’80% rispetto agli anni passati.
Ora, credere che la multinazionale operi questo lavoro solo su contenuti divisivi e pericolosi è illusorio. Il controllo – è Meta stessa a dirlo – è infatti su tutta l’informazione politica, civica e sociale. La multinazionale vuole infatti sapere di cosa stai parlando in quel post e poi, attraverso criteri di cui nessuno sa niente, decide quanta visibilità assegnargli. In questo schema, il fatto che centinaia di migliaia di persone abbiano espresso la chiara e libera volontà di ascoltare e leggere quanto dice una fonte attraverso segnali inequivocabili (esempio: seguire una pagina, interagire positivamente con i suoi contenuti, cercarla manualmente ecc.) risulta praticamente irrilevante: decide Meta a prescindere dalla loro volontà. E non spiega né a alla fonte né a lettori perché e per come prenda quella decisione.
L’unica cosa che Meta, all’epoca, spiegò (maldestramente) fu cosa a suo dire la motivò ad implementare tale policy.
Lo fece – paradossalmente – con un vecchio trucco che si usa spesso in politica: giustificare un intervento spiegando che esso non nasce motu proprio, ma su richiesta di altri individui, possibilmente spaventati e indifesi. In quella comunicazione si legge infatti a tutt’oggi che “il feedback che sentiamo è che le persone non vogliono che i contenuti politici prendano il controllo del loro feed di notizie”. Chi e quante fossero queste persone intervistate (due, centosessantasette, un miliardo e trecentomila?) – e dal cui feedback è nata una policy mondiale di controllo che tratta le persone come bambini incapaci di scegliere cosa leggere – non è dato saperlo, ma va notato l’uso strategico delle parole. Meta, non casualmente, usa infatti qui un termine forte: “prendano il sopravvento/controllo” (in inglese: take over). Dalla Treccani: “predominio, superiorità. avere il s. sull’avversario, sul nemico; prendere, mantenere il s., mettersi in posizione di vantaggio, di superiorità”. Tradotto: conflitto, paura, minaccia. Meta non poteva dunque non intervenire in difesa di quell’imprecisato numero di “persone” spaventate all’idea che la politica le soverchiasse.
Altresì la multinazionale, forse per eccessiva autoreferenzialità, poche righe più in basso faceva un grosso inciampo, ammettendo candidamente che in quella data l’ammontare dei contenuti a carattere “politico” rappresentava solo il 3% del totale. Mancavano quindi 48 punti percentuale ad un effettivo take over. Un po’ tantini. Un gap così ampio, dunque, fugava ieri e fuga oggi l’illusione di una reale minaccia di un presunto sopravvento e solleva legittimi dubbi sulle reali motivazioni che hanno spinto all’implementazione di tale policy, di cui dall’altro lato la pericolosità non lascia invece nessun dubbio.
Siamo infatti di fronte ad una multinazionale che tramite Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads rappresenta oggi la quota maggiore di un ristrettissimo oligopolio di un’infrastruttura molto delicata, quello dei social media, la quale si è autolegittimata a svolgere il ruolo di silenzioso e criptico controllore dell’informazione politica, che di fatto regola a suo piacimento, non sentendosi neppure in dovere di spiegare come lo faccia. Considerando che oggi milioni di persone solo nel nostro Paese si informano sui social media, e che sulla base di quanto letto formano un’opinione politica (quindi cosa votare), c’è quindi da allarmarsi e neppure poco. Chi controlla le fonti d’informazione può infatti controllare il voto, è lapalissiano. E per quanto Meta, una delle multinazionali più ricche e influenti del pianeta, sia certamente cambiata rispetto ai tempi della grave, gravissima vicenda di Cambridge Analytica, e che quindi oggi nessuno creda minimamente che intenda usare questa policy per controllare silenziosamente l’opinione pubblica, si rimane comunque perplessi all’idea che, teoricamente (si ribadisce: teoricamente), possa farlo. Allo stesso modo, nessuno oggi può garantirci che le diverse riduzioni di visibilità operate sulle fonti che trattano di politica (da circa il 50% all’80%), e che creano vantaggi competitivi enormi a quelle meno penalizzate, siano frutto di pura casualità e non di precise scelte. Non essendo le informazioni di questo sistema pubbliche, e vedendo noi solo il risultato da esso prodotto, potremmo solo fidarci della buona fede di Meta, la quale nega disparità di trattamento.
Dato però che in un sistema civile la buona fede non basta, la politica, su questo enorme problema, è giustamente intervenuta, recentemente. In Europa lo si è fatto tramite un’interrogazione alla Commissione presentata dall’eurodeputato Brando Benifei, dove si chiede conto di queste pratiche. A livello nazionale, invece, si sta lavorando a un esposto da presentare all’AGCOM e si è invece già depositata una proposta di legge di Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico, che impone a tutti i social media due principii tanto semplici quanto sacrosanti: quello della parità di trattamento e della trasparenza. Tolti i contenuti davvero pericolosi come quelli che violano la legge, quelli di incitamento all’odio o le fake news, tramite un articolato sistema di obblighi, divieti e meccanismi di garanzia si impone di non manipolare i flussi dell’informazione, lasciando ai cittadini la libertà di informarsi come meglio ritengono. Senza pericolosi paternalismi, di cui nessuna democrazia ha bisogno, specialmente in settori così delicati e critici.