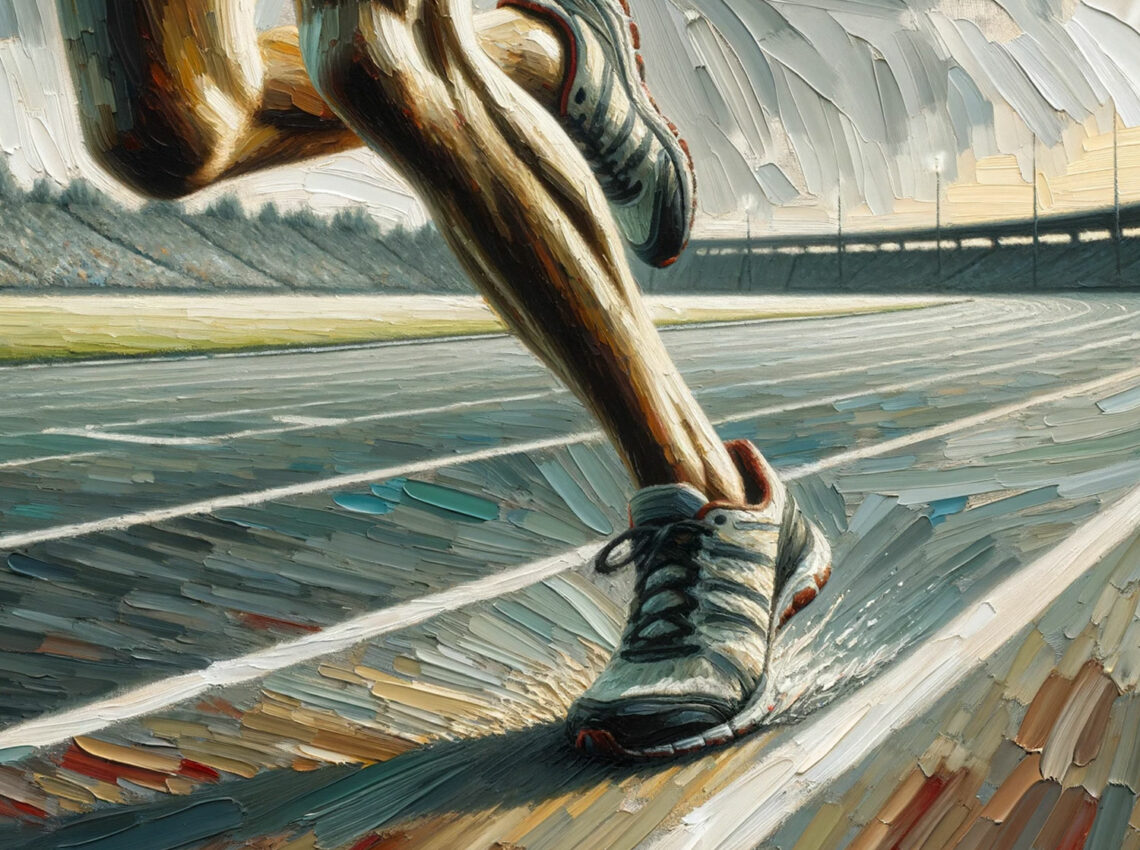Innovazione tecnologica e digitale: quanto possono far bene alla sicurezza delle nostre infrastrutture

In Italia siamo abituati a far bene e molto di più soprattutto dopo un grande evento calamitoso. Il mio riferimento è quello legato alla data del 14 agosto 2018: data che ricorda la tragedia del viadotto del Polcevera (il Ponte Morandi) e che segna un importante punto di svolta nel livello di cognizione dello Stato sulle “opere d’arte” in ferro e calcestruzzo che collegano intere aree del nostro Paese in cui rientrano i ponti, i viadotti, i cavalcavia stradali, autostradali e ferroviari.
Fu un momento di rassegnazione umana e allo stesso tempo di determinazione che obbligò moralmente sia l’apparato governativo che quello parlamentare a porre un punto alla fase di incertezza che ha preceduto il catastrofico evento e migliorare la condizione di sicurezza delle infrastrutture viarie e ferroviarie sulle quali giornalmente milioni di cittadini si spostano, noncuranti della reale sicurezza che quello stesso viadotto o cavalcavia possa realmente garantire loro.
Fu un momento di presa d’atto che qualcosa doveva cambiare. E fortunatamente fu così, qualcosa cambiò e ci fu un nuovo inizio in cui l’era della digitalizzazione tecnologica è diventata il punto focale.
Si iniziò a parlare e a scrivere leggi che comprendessero, a mio avviso, parole magiche come “monitoraggio dinamico e costante dello stato delle opere pubbliche anche attraverso l’uso di applicativi dedicati come sensori in situ e rilevazioni satellitari”.
È l’inizio di una nuova era, quella del monitoraggio dinamico e costante attraverso l’uso di nuove tecnologie. Una nuova era preceduta da quella in cui il concetto di monitoraggio era rappresentato solo da una “nicchia”.
In questa fase avveniristica, il concetto di monitoraggio cambia paradigma e si impone con un radicale cambio di visione fondandosi sulla conoscenza dei dati che, in alcuni casi, e fino a poco tempo fa, nemmeno esistevano!
Proprio così, prima del cosiddetto boom economico che ha caratterizzato l’Italia tra gli anni ’50 e ’60, le costruzioni in Italia venivano realizzate senza specifiche norme sulla durabilità, qualità dei materiali e senza una programmata attività manutentiva. Si è dovuto attendere il 1971, anno in cui venne emanata la legge 1086 che inserì l’obbligo del calcolo strutturale.
Per questi motivi, in alcuni casi ci si ritrova a partire dal punto zero, ovvero: casi in cui i progetti originali non corrispondono all’opera realizzata o, ancor peggio, casi in cui i progetti originali sono inesistenti !
Inoltre, se consideriamo la vetustà delle “opere d’arte” infrastrutturali esistenti sulla rete stradale, autostradale e ferroviaria del nostro Paese, possiamo dire ad oggi, con assoluta certezza, che almeno il 50% di esse ha un’età superiore ai 50 anni, contro la media dei Paesi del G7 che si attesta sui 20 o 30 anni.
Ecco perché il tragico evento del 14 agosto del 2018 ha di fatto “aperto gli occhi” delle istituzioni sul reale stato delle nostre infrastrutture incidendo sull’agenda politica da intraprendere per cercare di recuperare il recuperabile.
Così, come una Fenice, nasce l’idea di uno strumento tecnologico, open data, atto in primo luogo a censire l’esistente e in secondo luogo a catalogarne i dati dei rilievi che consentano di avere uno sguardo d’insieme certamente più attento e reale e che permetta, soprattutto, di intervenire secondo un’analisi prioritaria gli interventi da porre in essere.
Parlo di manutenzione programmata, concetto pressoché sconosciuto fino al giorno della tragedia del viadotto del Polcevera. Mi riferisco all’istituzione dell’AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche) disciplinato dall’articolo 13 del decreto-legge 28/09/2018 n.109 (cd. decreto Genova) attuato successivamente nel 2019 con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 430.
Si tratta di un contenitore informatico riguardante ogni informazione utile a comprendere lo stato di un’opera, il suo grado di sicurezza per la pubblica incolumità, il tipo di reazione che il manufatto genera al verificarsi di eventi ad esso circostanti, in altre parole: la sua resilienza.
Tutto questo oggi è possibile grazie all’ausilio di nuove tecnologie sensoristiche, satellitari, che sfruttano la scienza, l’informatica, la digitalizzazione, iCloud e anche l’intelligenza artificiale e blockchain che si adattano perfettamente al citato AINOP. E non è tutto.
Per dare seguito al percorso iniziato, nel luglio del 2022 sono state adottate, con decreto ministeriale, le Linee guida per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. Come dicevo, si tratta di una nuova era che, con un pizzico di orgoglio per me che le ho viste nascere, si affaccia nel campo dell’edilizia pubblica e che con l’affinamento delle migliori pratiche tecnologiche riuscirà a garantire maggiore sicurezza agli utenti, maggiore resilienza dei manufatti e migliori prospettive di resa in termini di vita utile dell’opera stessa.
Sempre in un’ottica di sicurezza e resilienza delle infrastrutture autostradali, Aspi, al fine del monitoraggio della rete, si avvarrà di una piattaforma che utilizzerà l’intelligenza artificiale di IBM, di droni, di IoT (Internet of Things) e modellazione digitale 3D per consentire le attività di sorveglianza e monitoraggio di oltre 4.500 opere presenti sulla rete autostradale di ASPI.
Per concludere, va data menzione al programma sperimentale “Falco” di Gruppo Autostrade per l’Italia che, tramite l’impiego di droni, permette di inviare flussi video in tempo reale direttamente al Centro Radio Informativo, consentendo di monitorare lo stato della viabilità anche in tratti autostradali lungo i quali non sono disponibili telecamere. L’iniziativa, avviata in area ligure, ha previsto l’esecuzione di voli notturni e il monitoraggio di transiti eccezionali anche in corrispondenza di cantieri.
È il caso di dirlo: è l’inizio di una nuova era!