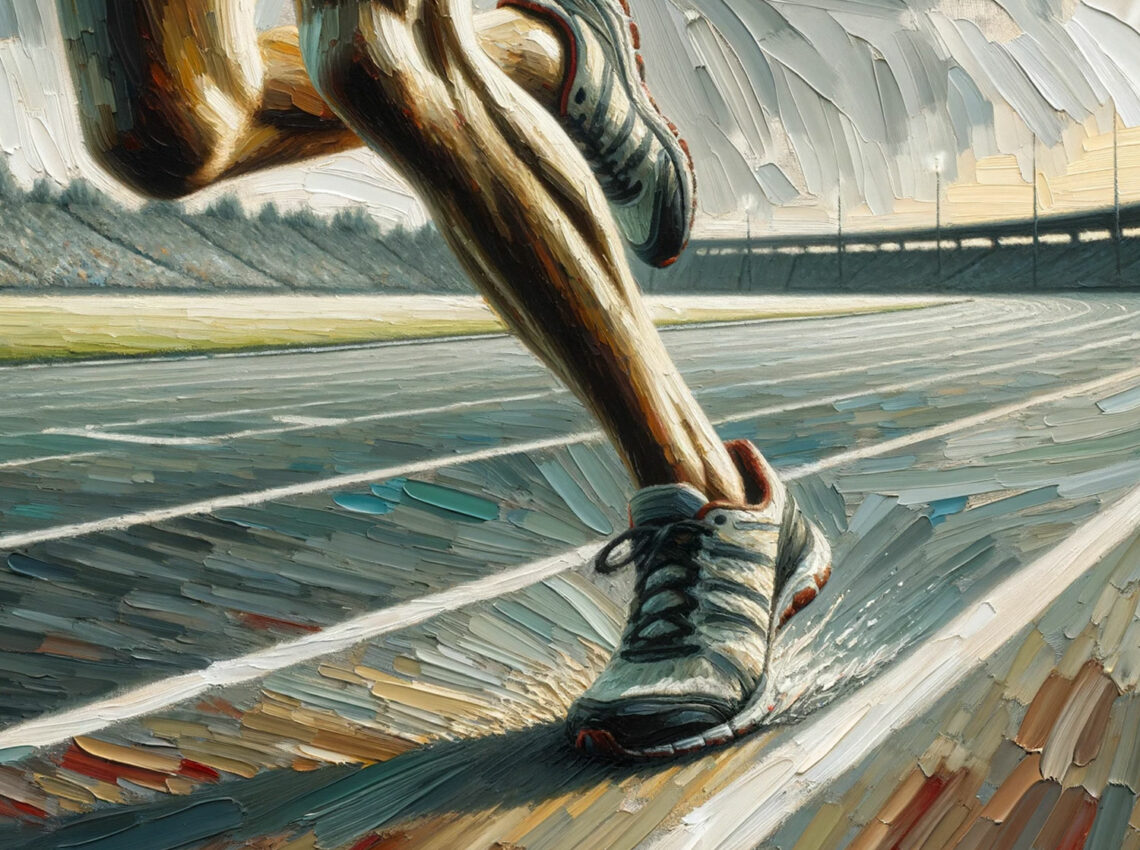L’Allegoria del Buono e del Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti. Una delle prime espressioni di “arte civile” nella storia dell’arte.

L’Allegoria del Buono e del Cattivo Governo, con i rispettivi effetti nella città e nella campagna, è un ciclo di affreschi realizzato nel Palazzo Pubblico di Siena tra il 1338 ed il 1339 da Ambrogio Lorenzetti, il miglior pittore senese dell’epoca. Il ciclo pittorico – che doveva ispirare l’operato dei governatori cittadini che si riunivano in queste sale e che al contempo intendeva coinvolgere il pubblico in riflessioni relative al coevo contesto sociopolitico – si trova all’interno della Sala del Consiglio dei Nove, detta anche “della Pace”. Gli affreschi furono commissionati dal Governo della Città e sono una delle prime espressioni di arte civile nel Medioevo, con un chiaro effetto didascalico: ciò è ben evidente confrontando le raffigurazioni del Buon Governo e del Cattivo Governo, entrambe popolate da personaggi allegorici identificabili grazie alle didascalie. Il ciclo inoltre, rappresenta una delle prime opere di carattere totalmente laico e di contenuto non più solo religioso, ma politico-filosofico nella storia dell’arte in Italia.
Analizzando l’Allegoria del Buon Governo, notiamo subito che in posizione elevata a sinistra si trova la Sapienza Divina, incoronata, alata e con un libro in mano che tiene una bilancia sui cui piatti due angeli amministrano i rami della giustizia secondo la tradizione aristotelica: distributiva e commutativa. La bilancia è regolata dalla Giustizia in trono, virtù ed istituzione cittadina che però è solo amministratrice, essendo la Sapienza Divina l’unica a reggere il peso della bilancia e verso cui la Giustizia stessa volge lo sguardo. Dalle vite dei due angeli partono inoltre due corde che si riuniscono per mano della Concordia, diretta conseguenza della Giustizia ed assisa su una sedia con in grembo una pialla, simbolo di uguaglianza e livellatrice dei contrasti. La corda è tenuta in pugno da ventiquattro cittadini allineati al fianco della Concordia e simboleggianti la comunità di Siena. Al termine del corteo troviamo il simbolo della città, la lupa con i due gemelli, sopra il quale è il Comune di Siena, rappresentato da un monarca in maestà identificato con la scritta C(omunis) S(senarum) C(ivitas) V(irginis): è vestito in bianco e nero, chiaro richiamo alla balzana, simbolo di Siena, ed in mano ha uno scettro ed uno scudo con l’immagine della Vergine col Bambino e due angeli; in testa ha un copricapo di pelliccia, riferimento allo stato di giudice, mentre al suo polso è legata la corda della giustizia consegnatagli dai cittadini stessi. Il Comune è inoltre protetto e ispirato dalle tre Virtù Teologali, rappresentate alate in alto: Fede, Speranza e Carità, mentre ai suoi lati siedono, su un ampio seggio coperto da un pregiatissimo tessuto, le quattro Virtù Cardinali: Giustizia, Temperanza, Prudenza e Fortezza. A loro si uniscono altre due Virtù non convenzionali, ovvero la Pace, semisdraiata in una posa sinuosa su un cumulo di armi e con il ramo di ulivo in mano, e la Magnanimità, dispensatrice di corone e denari, mentre più in basso troviamo l’Esercito della città, composto dalla cavalleria e dalla fanteria, che sottomette un gruppo di uomini.
Possiamo senza dubbio affermare che la corda – che unisce tutte le figure presenti nella composizione – rappresenta un elemento centrale nel dipinto poiché simboleggia l’unione tra la Giustizia ed il Comune, inscindibili e tenuti insieme dai cittadini in stato di armonia. In questo modo, secondo il modus pingendi tipico medievale, l’affresco esprime didascalicamente la percezione della giustizia nella città dell’epoca.
Dipinta in maniera perfettamente speculare è l’Allegoria del Cattivo Governo, che permette così il confronto diretto tra le due rappresentazioni: al centro siede in trono la personificazione della Tirannide, figura mostruosa con le zanne, le corna, gli occhi strabici ed i piedi artigliati: non ha alcuna corda vincolante e ai suoi piedi è accasciata una capra nera demoniaca, antitetica alla lupa. Sopra di lei volano tre Vizi alati: l’Avarizia, con un lungo uncino per arpionare avidamente le ricchezze e due borse le cui aperture sono strette in una morsa, la Superbia, con la spada e un giogo, e la Vanagloria, con uno specchio per ammirare la propria bellezza materiale e una fronda secca, segno di volubilità. Al fianco della Tirannide siedono le personificazioni delle varie sfaccettature del Male: a partire da sinistra troviamo la Crudeltà, intenta a mostrare un serpente ad un neonato; il Tradimento, con un agnellino tramutato in scorpione a livello della coda, simbolo di falsità; la Frode, con le ali ed i piedi artigliati; il Furore, con la testa di cinghiale, il torso di uomo, il corpo di cavallo e la coda di cane, simbolo di ira bestiale; la Divisione, con il vestito a bande bianche e nere verticali e con la sega; la Guerra, con la spada, lo scudo e la veste nera. In basso troviamo infine la Giustizia, a terra, soggiogata, spogliata del mantello e della corona, con le mani legate, i piatti della bilancia rovesciati e l’aria mesta: è tenuta con una corda da un individuo solo – piuttosto che dalla comunità – e accanto a lei sono le vittime del malgoverno, ovvero i cittadini.
Segue la parte più lacunosa e mal conservata dell’affresco ma quanto fin qui rappresentato funge da monito per lo spettatore, che in questo modo coglie l’orrore ed il timore di un cattivo governo nell’amministrazione della città.