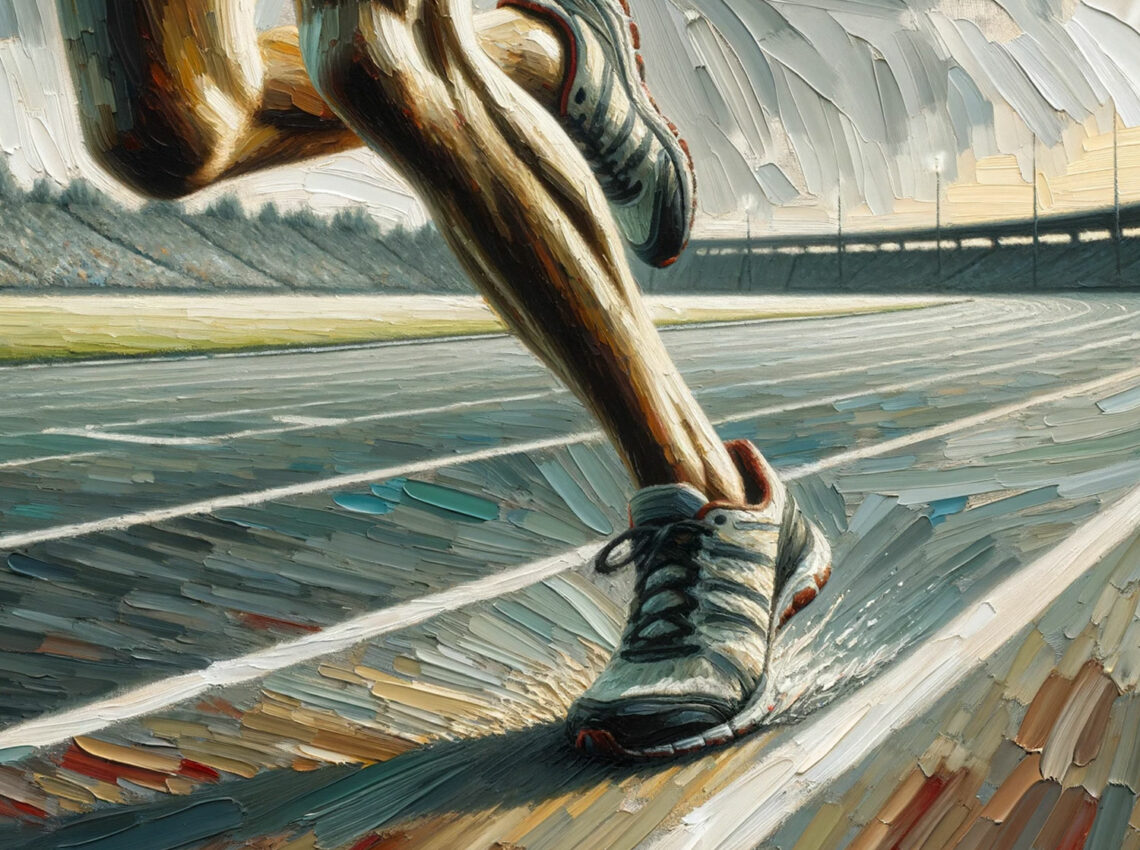Le implicazioni sociali della trasformazione digitale

La centralità del ruolo della politica in questo tempo di profonda e veloce trasformazione digitale ha faticato a conquistare il ruolo che si merita e che le compete. Addirittura l’etica, soprattutto in riferimento all’esplosione dei sistemi di intelligenza artificiale, ha goduto di un rinnovato interesse prima e più dell’aspetto politico.
La necessità di un’azione politica saggia ed efficace appare subito evidente a chi riconosce come la trasformazione digitale in atto mostri oggi le sue problematicità anzitutto nelle conseguenze sociali più che in presunti apocalittici scenari post umani. Questioni come la raccolta, il possesso e la custodia dei dati, così come la tutela dei minori e delle persone fragili, l’aumento delle disparità e il rischio della riduzione delle libertà individuali, l’indebolimento dei processi democratici, sono solo alcuni dei temi che chiedono un’attenzione urgente e grave.
Questa attenzione deve inoltre fare i conti con un dettaglio decisivo. Le tecnologie non sono neutre: esse riflettono visioni culturali e antropologiche, modellano rapporti economici e di potere. In questo senso esse plasmano la società non soltanto a secondo del buono o cattivo utilizzo che se ne fa (vero ma insufficiente e ingenuo), ma nel modo stesso con cui sono progettate, realizzate e diffuse.
La politica guadagna finalmente un ruolo centrale in questa trasformazione mostrando un limite con cui deve fare i conti, soprattutto in questo tempo post ideologico: il rischio della mancanza di una visione complessiva entro cui iscrivere la regolamentazione giuridica. È normale e non deve spaventare il fatto che lo sviluppo tecnologico sia incredibilmente più veloce delle sue regolamentazioni. La sindrome dell’inseguimento si supera se la politica mostra la sua reale forza: non una eccezionale capacità predittiva che forse non le compete, bensì una visione di società entro cui è possibile accogliere, sostenere e guidare verso il bene comune anche i fenomeni più innovativi e sorprendenti.
In modo specifico, la trasformazione digitale in atto richiede una visione che tenga conto della duplice globalità che caratterizza il digitale e i suoi effetti sociali.
La trasformazione in atto è un fenomeno globale anzitutto nella sua diffusione istantanea. A differenza di altre grandi rivoluzioni tecnologiche, questa è stata da subito universale. Oggi quasi il 70% della popolazione mondiale ha in tasca uno smartphone ed è connesso a Internet. Culture, lingue, tradizioni, società, fedi, cosmologie, economie: una più diversa dall’altra, tutte contenute e mediate in un unico oggetto e connesse in un’unica rete.
La tecnologia è poi globale nelle forme con cui si realizza. La quasi totalità degli apparati digitali in nostro possesso è stata progettata in centri di ricerca (spesso privati) occidentali, realizzati in fabbriche asiatiche con minerali quasi sempre africani, commercializzati da multinazionali che, molto frequentemente, hanno un CEO indiano.
La visione richiesta oggi all’attore politico che deve sostenere, accompagnare e regolamentare la transizione digitale in atto, non può non tenere conto della qualità globale del fenomeno in atto, in un tempo in cui il globalismo ha obiettivamente mostrato i suoi limiti. La speranza di gestire questo fenomeno in modo anzitutto locale, accentuando le differenze, mettendo le culture in gara se non in contrapposizione, indebolendo i soggetti sovranazionali che possono offrire sguardi più ampi, è quantomeno ingenua, certo fallimentare.
Oggi abbiamo bisogno di visioni capaci di tenere insieme (non di contrapporre) globale e locale, di far dialogare culture e tradizioni diverse. Uno studio comparativo dei documenti europei e cinesi di regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale ha mostrato una certa coincidenza nei principi, espressi però con parole diverse. In occidente il primo criterio è l’affidabilità, in Cina l’armonia. Dalla capacità di andare oltre l’affermazione del primato dell’uno sull’altro per cercare forme di sintesi più ampia verrà la possibilità di offrire una visione adeguata e responsabile del bene di tutti e non di una sola parte per gestire questa transizione.
In questo senso ben vengano documenti quali l’europeo AI act che, al netto dei limiti di un complesso testo frutto di un lungo lavoro di mediazione, rappresenta un primo risultato in questa linea.
Un mondo piccolo, come è diventato il nostro, impone responsabilità grandi e chiede persone capaci di visioni adeguate.