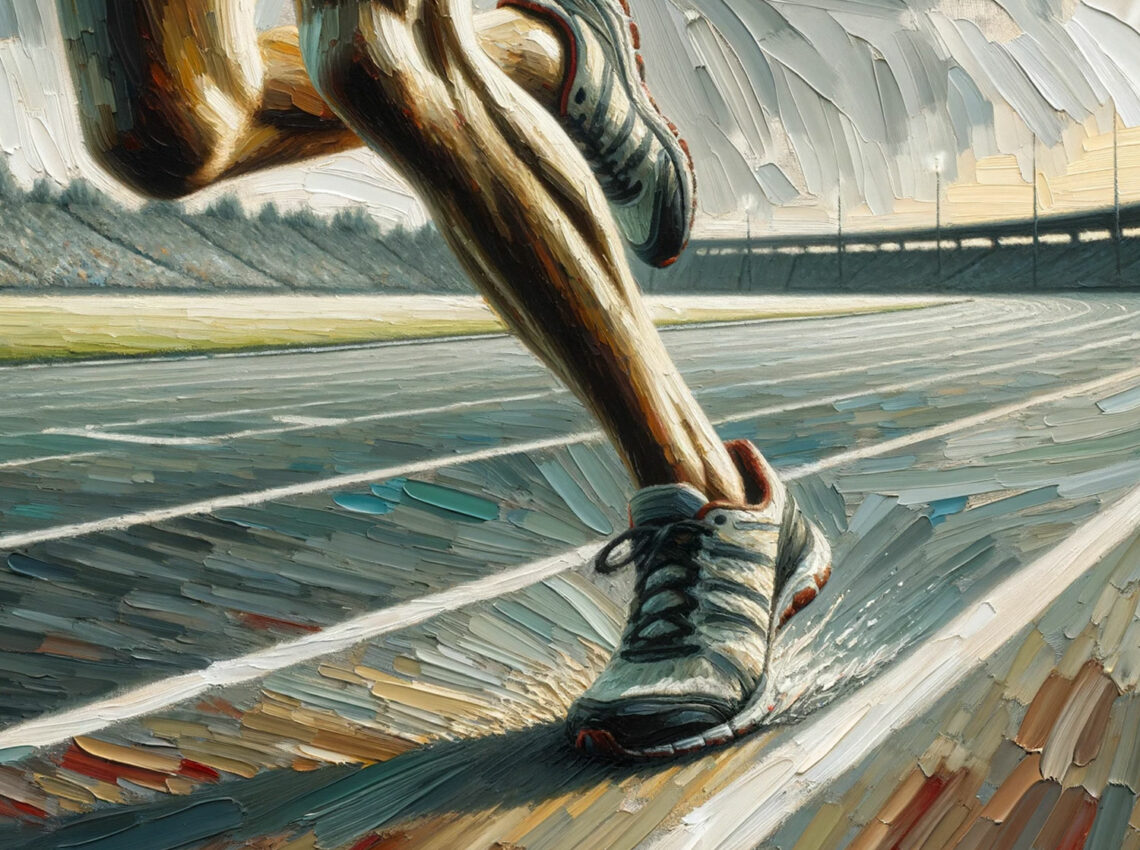L’economia di ChatGPT a prova di Italia
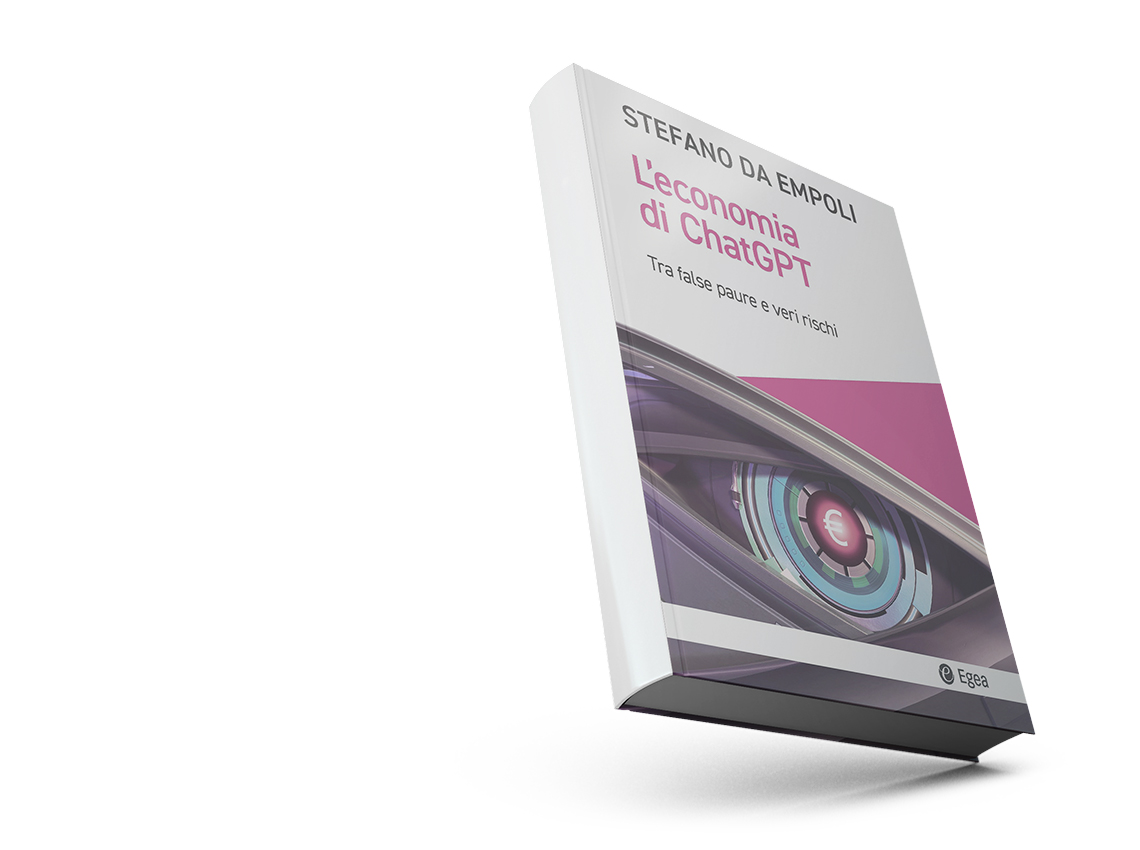
ABSTRACT – La velocità unita alla sofisticazione dell’IA generativa nonché la sua facilità d’uso offrono un’occasione senza precedenti per determinare un salto della produttività in tutte le organizzazioni. Purché si ripensino profondamente i sistemi di istruzione e formazione, rendendo i lavoratori futuri e attuali capaci di estrarre il meglio dalle macchine. Con le quali la collaborazione deve necessariamente prevalere sulla competizione.
L’enorme clamore mediatico suscitato dall’uscita di ChatGPT e poi proseguito con il rilascio di altri prodotti in grado di generare in pochi secondi testi, immagini, video, codici e quant’altro ha riportato l’intelligenza artificiale (IA) al centro del discorso tecnologico, dopo qualche anno di appannamento. Dopo le promesse (per ora) non mantenute dell’auto a guida autonoma e quando qualcuno già ipotizzava un nuovo inverno dell’IA all’orizzonte, è giunto il lancio di ChatGPT, avvenuto il 30 novembre 2022, a scuotere l’immaginazione delle persone comuni, per due motivi fondamentali. In primo luogo, nessuno o quasi si aspettava un livello qualitativo così alto. È vero che ChatGPT a volte farnetica e spesso dice banalità ma risponde a un incrocio tra sofisticazione linguistica e velocità di esecuzione che non può che apparirci strabiliante. Secondo (ma non meno importante), tutto questo succede con una facilità d’uso senza precedenti. Sempre fino a quella fatidica data immaginavamo il dialogo con le macchine come qualcosa di riservato a una classe di iniziati. L’informatico in questo senso era come il sacerdote nella Chiesa cattolica e ChatGPT ha rappresentato per l’IA la sua riforma protestante.
Improvvisamente è caduta qualsiasi intermediazione e chiunque poteva mettersi con il suo dispositivo a interrogare la macchina.
Spesso per chiedere sciocchezze. Per mesi i giornali hanno riferito dialoghi tra l’assurdo e il frivolo con il chatbot di OpenAI. Che era finito per diventare un vero e proprio fenomeno di costume. Con enorme pubblicità che tuttavia, come gli esperti di marketing sanno perfettamente, può diventare facilmente un’arma a doppio taglio. Più andava avanti questa narrativa, maggiori erano i difetti riscontrati nello strumento. E dunque era messo in scena un dibattito apparentemente surreale. Da un lato intellettuali e anche qualche scienziato manifestavano preoccupazioni sul futuro dell’umanità, tanto era potente la nuova meraviglia dell’informatica. Dall’altro ChatGPT e i suoi simili erano sempre di più oggetto di scherno, quasi come pugili ormai sfiancati pronti ad andare KO al prossimo cazzotto ben assestato.
Peccato che questa narrazione, fatta di iperboli da un lato e dall’altro, sia profondamente sbagliata, portando paradossalmente a un risultato convergente, quello di respingere la tecnologia quando invece servirebbe l’esatto opposto, cioè testarla e usarla nella maniera più appropriata per i propri bisogni. Perché la vera sfida non è quella tra persone e macchine bensì quella di consentire alle persone di migliorare i propri risultati o di realizzare meglio i propri desideri grazie all’aiuto delle macchine. In questa prospettiva, la missione è possibile, purché si investano risorse adeguate in istruzione e formazione, a beneficio dei lavoratori di domani e di quelli di oggi. Ma a parte i soldi serve un cambio di mentalità in un Paese come l’Italia, che ha ordinamenti scolastici e universitari rigidi e stratificati nella storia e un sistema di formazione che ha punte di eccellenza quasi esclusivamente concentrate nelle grandi imprese.
Se a scuola serve dare agli studenti soprattutto la capacità critica di interagire con l’IA, nelle università e negli ITS è giusto offrire strumenti professionalizzanti. In una logica che tuttavia deve essere verticale (più corsi di laurea e post-laurea nonché cattedre dedicate) quanto orizzontale (tutti i percorsi, anche quelli potenzialmente più lontani dall’IA, con quest’ultima devono fare i conti). L’obiettivo dunque deve essere quello di creare più specialisti dell’IA ma anche e per certi versi soprattutto specialisti di altre discipline che abbiano gli strumenti di base per utilizzare al meglio l’IA.
Rispetto alla formazione, innanzitutto il target prioritario, e invece spesso trascurato, di ogni azione dovrebbero essere i vertici delle organizzazioni. Pensiamo alle centinaia di migliaia di piccoli imprenditori ai quali andrebbero dati gli strumenti innanzitutto per orientarsi e orientare i propri investimenti. Spetta infatti a loro (e ai loro colleghi di realtà più grandi) ripensare non solo i profili tecnologici della propria azienda ma anche due elementi ancora più trasformativi, cultura e organizzazione. Ecco allora che a quel punto la formazione aziendale uscirebbe dallo stato di Cenerentola nella quale attualmente si trova nella stragrande maggioranza delle organizzazioni.