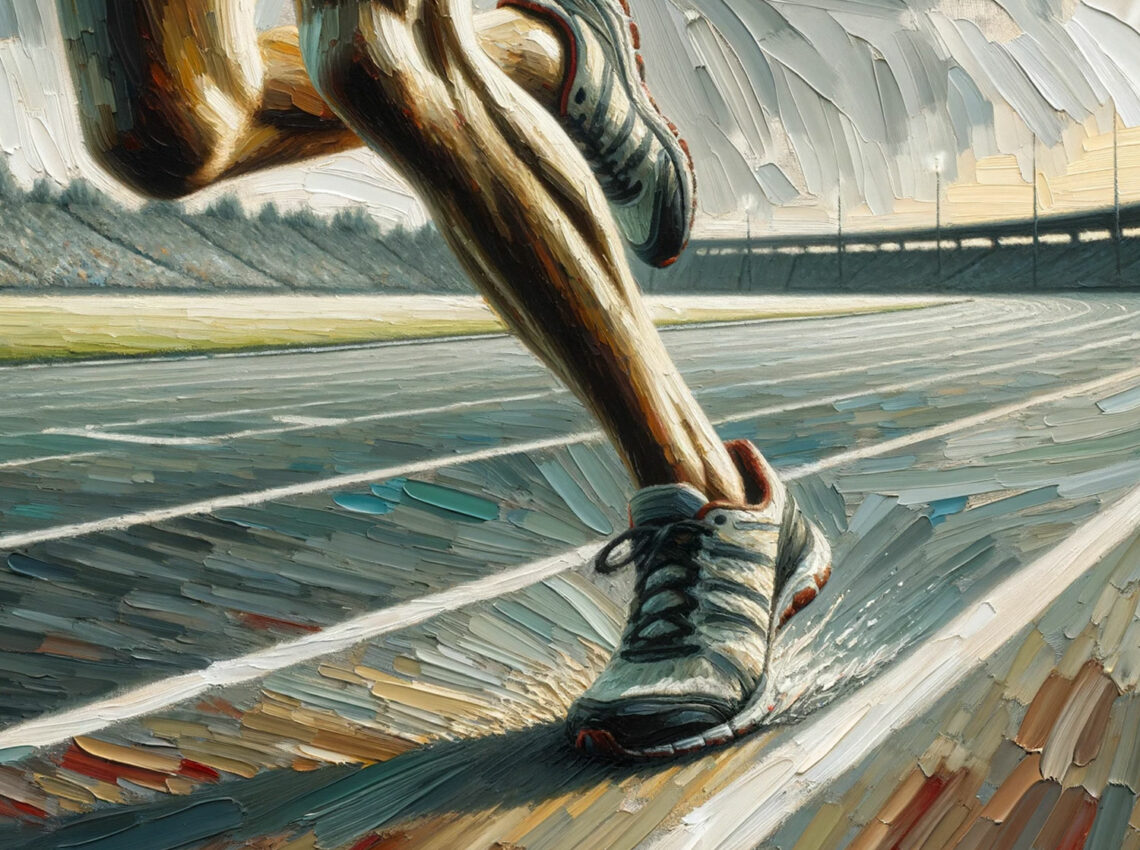Navigare il futuro: da apocalittici a integrati nella società digitale

Esattamente sessanta anni dopo la pubblicazione del celebre saggio di Umberto Eco “Apocalittici e integrati: comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa” che per la prima volta ha diviso drasticamente in due la popolazione tra “apocalittici e integrati” in base all’atteggiamento critico o ottimistico nei confronti dei cambiamenti in atto, anche il nostro paese torna oggi a vivere una divisione radicale a causa di come vengono percepite dalle diverse persone le straordinarie potenzialità delle innovazioni che la transizione tecnologica sta rapidamente portando nelle nostre vite. La fantascienza bussa alle porte delle nostre case e ci permette di realizzare non solo quello che fino a oggi abbiamo visto solo nei film ma anche molto di più.
E se è vero che la “Terza legge di Clarke” ci ha insegnato come “ogni tecnologia sufficientemente avanzata sia indistinguibile dalla magia”, due sono sempre state le conseguenze nella vita sociale di questo effetto speciale: da una parte ci sono i maghi che ne comprendono e governano il funzionamento e lo sviluppo e dall’altra tutti coloro che a bocca aperta ne subiscono gli effetti e ne vengono determinati senza comprenderne le ragioni. Il bivio che abbiamo di fronte è esattamente questo: da che lato della magia vogliamo collocarci? E in che direzione vogliamo orientarla, ben sapendo che esistono due principali filoni della fantascienza, tra loro antitetici: la fantascienza distopica, che ci indica come potrebbe andare tutto male e quella utopica, che ci indirizza verso tutto quello che vorremmo diventare.
Numeri alla mano se consideriamo il valore aggiunto che l’impatto delle nuove tecnologie può avere sulle nostre esistenze – ad esempio, si è stimato che solo la Pubblica Amministrazione italiana potrebbe grazie all’avvento dell’intelligenza artificiale potrebbe sviluppare, a parità di ore lavorate, 312 miliardi di euro di valore aggiunto ogni anno – allora non siamo forse di fronte all’occasione delle occasioni, alla possibilità di realizzare non solo un orizzonte utopico ma addirittura l’Utopia delle Utopie, quella di San Tommaso Moro, trasformare il nostro mondo terreno, segnato da ingiustizie e diseguaglianze sempre più crescenti, ferito e malato, percorso da guerre e conflitti nel luogo dove l’uomo scopre finalmente come cominciare a porre rimedio ai mali che ha generato perché non è forse vero che “così facilmente s’acquisterebbe il vivere se il desio di accumulare denari non impoverisse gli altri”? Per riuscire però a sviluppare tutte le potenzialità delle nuove opportunità dobbiamo completamente cambiare impostazione: per prima cosa dobbiamo metterci a studiare. Abbiamo bisogno di aprire gli occhi sul cambiamento che stiamo vivendo e porci l’obiettivo di crescere, non solo nelle competenze digitali, che vedono gli italiani in fondo alle classifiche europee, ma in un processo di vera e propria alfabetizzazione generale: termini come “Intelligenza artificiale”, “Cloud”, “Cybersicurezza” dovrebbero essere conosciuti e utilizzati da tutti in termini propri e compiuti come tessere indispensabile di uno stesso mosaico, il mosaico su cui camminiamo ogni giorno. Il primo effetto sarebbe finalmente un corretto inquadramento. Infatti, di fronte a concetti spesso complessi la naturale reazione è l’assenza di collegamento: “già fatico a capire che cos’è una cosa, figurarsi se riesco a metterla in correlazione con un’altra”. Questa autodifesa dalla complessità produce un effetto devastante nel dibattito pubblico che viene spezzettato in mille aspetti e invece di diventare largo, sociale, popolare resta appannaggio di pochi addetti ai lavori.
Vediamo ad esempio il paradosso di quello che sta avvenendo sul 5 G, ogni giorno siamo invasi e pervasi da una pioggia di fake news rilanciate sui social che ci dicono che distrugge alberi, api, causa orribili malattie, addirittura avrebbe provocato il Covid, ma al tempo stesso non siamo in grado di collegare la necessità di un salto in avanti della nostra connettività e le potenzialità del cloud alle centinaia di servizi applicativi verticali che dalla salute ai trasporti, dall’educazione all’agricoltura potrebbero rivoluzionare, in meglio, la nostra esistenza. La parcellizzazione dell’inquadramento ci impedisce di vedere il complesso dei benefici che solo insieme le innovazioni tecnologiche che stiamo vivendo possono generare. Nel migliore dei casi riusciamo a ottenere gli strumenti per confutare le notizie false ma fatichiamo anche solo a intravedere tutto quello che nascondono. Tutto questo produce un vero e proprio corto circuito comportamentale in ambito, ad esempio, della cybersicurezza.
Nella dimensione digitale ci esponiamo a rischi immensi che mai accetteremmo nella dimensione fisica, e consideriamo per le nostre attività sociali ed economiche digitali, sempre più centrali e ormai interconnesse a quelle che viviamo negli spazi fisici, la sicurezza un servizio accessorio e non essenziale a differenza di quello che consideriamo nella nostra vita offline. In questo scenario è fondamentale la scelta di Enrico Letta, nel report elaborato per i leader europei “Much more than a market”, di considerare che il futuro dell’Europa passa dal riconoscere pienamente una nuova quinta libertà, al fianco della libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali: la libera circolazione dell’innovazione e della conoscenza. Perché rafforzamento del mercato unico europeo e politico istituzionale dell’Unione europea sono due facce della stessa medaglia, indispensabile per permettere al nostro continente di riuscire a reggere il passo nella transizione digitale e climatica, senza smarrire la propria dimensione sociale e la propria capacità economica di competere su scala globale. Non possiamo limitarci a regolare uno spazio che non stiamo occupando pienamente.
Per portare la storia e i valori europei nel futuro dobbiamo dotarci di strumenti adeguati per arrivarci direttamente e non solo per esserci semplicemente portati da qualcun altro.
Per questo anche in Italia dobbiamo porci un tema di Governance, come abbiamo fatto attraverso la proposta a prima firma di Antonio Nicita, Lorenzo Basso e Antonio Misiani di Digital Innovation Act che stiamo discutendo proprio in queste ore al Senato e che abbiamo depositato anche alla Camera dei Deputati insieme alle altre iniziative, tra qui quella del “watermark” per assicurare la trasparenza dei contenuti generati dall’IA, che stiamo portando avanti a prima firma della Vice Presidente Anna Ascani: serve al più presto una voce istituzionale unica, così come serve un’unica politica degli incentivi necessari a rendere sostenibile la transizione digitale, anche e soprattutto per quei soggetti che non sono in grado da soli di reggere il passo e rischiano così di restare esclusi dai benefici. Al tempo stesso serve investire sulle intelligenze, tutte le intelligenze, artificiali e non, anche e soprattutto l’intelligenza naturale, che è il fattore abilitante, l’elemento indispensabile per permettere alle lavoratrici di oggi e di domani di restare nel “loop”, nel percorso, nel processo, di essere in grado di acquisire, elaborare e gestire tutte le nuove informazioni che sono e saranno sempre più necessarie. In conclusione, per affrontare le sfide che abbiamo di fronte dividerci tra apocalittici e integrati non aiuta e non basta, abbiamo bisogno di rinunciare sia agli allarmismi che alle ingenuità. Protezione e innovazione non sono termini antitetici, anzi, l’innovazione è oggi l’unica strada possibile che può consentirci di proteggere anche i più deboli e i più fragili, di compiere tutti insieme un salto in avanti, senza lasciare larga parte di noi indietro. Ed è solo sciogliendo questo equivoco che anche il dibattito politico italiano potrà finalmente compiere un effettivo salto di qualità. Da questo punto di vista l’azione di pungolo strategico che come Partito Democratico stiamo portando avanti dall’opposizione può aiutarci a ottenere due effetti: costruire un insieme di proposte normative utili per il presente e per il futuro che favoriscano un confronto politico e parlamentare di merito e possano delineare nuovi tasselli fondamentali per la costruzione di un programma alternativo di Governo, al tempo stesso ci consente di svolgere un ruolo di stimolo, anche metodologico, verso l’attuale maggioranza per spingerla ad affrontare insieme temi che non devono e possono continuare a essere considerati separatamente, in compartimenti stagni che limitano fortemente le potenzialità che l’innovazione può già portare nella vita di ciascuno di noi.