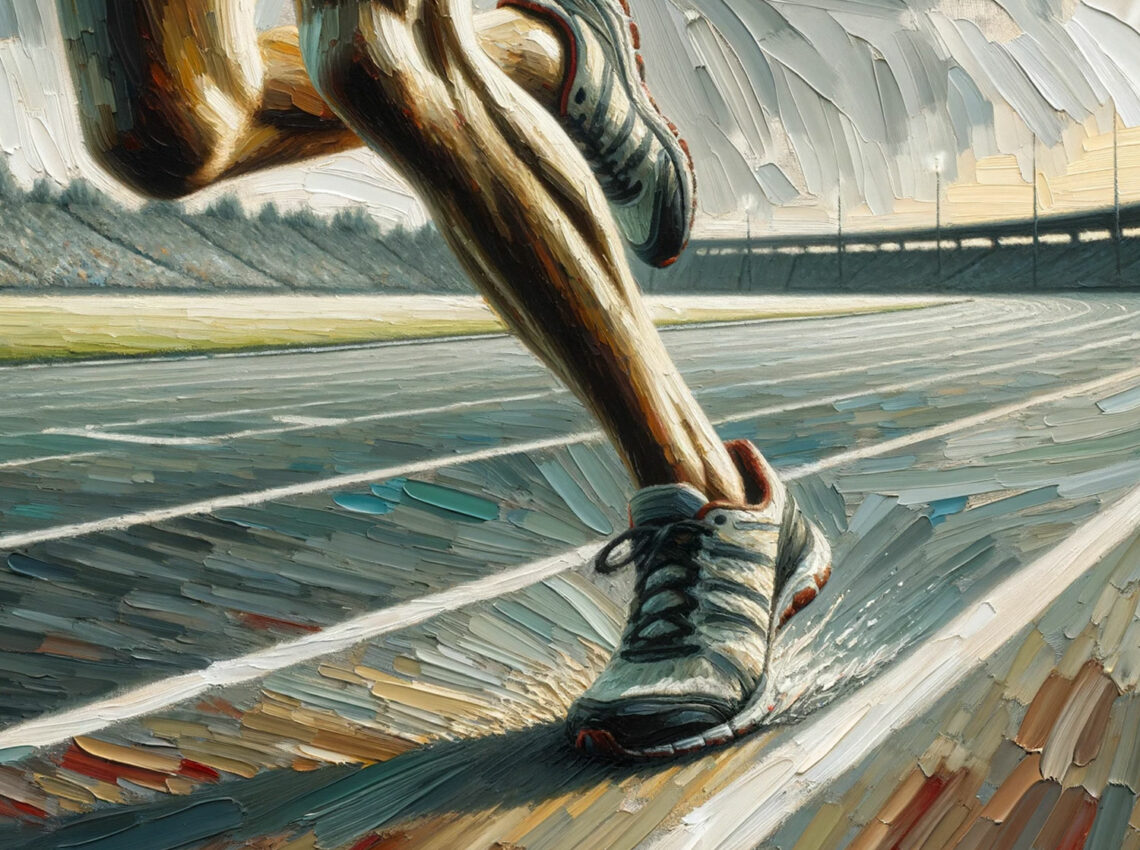Oltre la tecnologia: innovazione, politica e il futuro dell’Europa

Diciamo innovazione e pensiamo a una tecnologia nuova. Un riflesso incondizionato del tecnoumanesimo al quale, tuttavia, dovremmo resistere. Perché tutto ciò che abbiamo sotto gli occhi muta continuamente, si trasforma tra le nostre mani, nonostante possiamo provare il desiderio di fermarlo. La tecnologia ha un ruolo rilevante ma non esclusivo. I rapporti sociali mutano anche a prescindere dalle piattaforme “social” e l’innovazione sociale riguarda la democrazia e l’economia. Se accettiamo che il divenire prevale sulla stabilità, il problema che dobbiamo porci è di governare la direzione del movimento: dove vogliamo andare? In quali condizioni? Come orientare le risorse in gioco perché il cambiamento vada nella direzione auspicata?
Sono domande genuinamente politiche, perché riguardano il destino della comunità. E pertanto costituiscono il campo d’azione della politica e in particolare del legislatore. Due ex primi ministri italiani, Mario Draghi ed Enrico Letta, a metà aprile, hanno relazionato la Commissione e il Consiglio europeo sulle sfide della competitività e del mercato unico, ed entrambi hanno preso le mosse dalla constatazione che il mondo è molto cambiato rispetto al tempo in cui l’Unione europea è nata. Entrambi hanno invocato regole nuove, politiche diverse e maggiore integrazione per garantire decisioni efficaci e tempestive.
Per entrambi le nuove regole sono uno strumento, una condizione, rispetto al fine di assicurare agli europei un futuro di prosperità attraverso un progresso che ha come motore l’innovazione.
In particolare, per l’energia e il digitale. Energia e digitale sono pervasivi, riguardano qualsiasi attività svolgiamo e ogni momento della nostra vita (si stima che ciascuno di noi utilizzi quotidianamente 250 volte più energia di quella che usavano i nostri avi all’inizio del Novecento, di fatto limitata alle calorie che ingerivano con il cibo).
Tuttavia, il ruolo del legislatore rispetto a queste sfide può essere interpretato in modi diversi. Prendiamo il settore dell’automobile: il policy maker che abbia a cuore il contrasto al cambiamento climatico può decidere di definire per questa industria degli obiettivi, per esempio dei limiti all’inquinamento prodotto da un veicolo, oppure può decidere quale debba essere la tecnologia che tutti gli europei dovranno usare – per esempio l’auto elettrica. Sono due modi molto diversi di intendere il ruolo. Nel primo caso, il policy maker lascia che la comunità delle imprese e dei consumatori (parafrasi per designare il mercato) trovi la soluzione più efficace per conseguire l’obiettivo. Nel secondo, il legislatore ritiene di sapere meglio di chiunque altro e in anticipo rispetto a chiunque altro quale sia la tecnologia migliore (più efficace, più rapida, meno costosa). Nel secondo caso, rischia (con elevata probabilità) di sbagliare e di fare danni enormi alla comunità che deve sottostare alle nuove regole.
In altre parole, il legislatore deve decidere se impegnarsi a disegnare un contesto efficiente ed equo nel quale gli attori economici interagiscono liberamente per perseguire obiettivi comuni in vista di un bene maggiore oppure se dettare in modo dettagliato che cosa gli stessi attori devono fare e come devono farlo nella loro vita quotidiana.
Se guardiamo a un altro settore verticale, quello delle telecomunicazioni, oggetto di un capitolo specifico del rapporto “Much More Than a Market” di Enrico Letta, ci troviamo a constatare che le regole del gioco hanno portato l’intera industria sul baratro dell’insostenibilità economica, mettendo a repentaglio gli ingenti investimenti necessari per tenere l’Ue al passo di altre regioni del mondo. Queste regole sono state fissate all’inizio del millennio per favorire la riduzione dei prezzi dei servizi al consumo. E hanno funzionato. Ma, come un trattore al quale non è stato spento il motore, hanno continuato a triturare la capacità di innovazione e investimento del settore, provocando la scomparsa di interi comparti e di molte aziende, con l’effetto ultimo di rallentare gli investimenti privati e peggiorare le prospettive dei consumatori in termini di qualità e quantità dei servizi disponibili in futuro.
Tanto Letta quanto Draghi oggi invitano ad aggiornare regole che sono state concepite per un mondo che non c’è più (nel quale le tariffe erano tra le più care rispetto ad altre aree economiche ma che era anche la casa di alcune tra le aziende più importanti nel settore su scala globale, con benefici in termini di occupazione e di competitività internazionale).
Negli ultimi anni il dibattito pubblico intorno al ruolo dell’Ue si è compiaciuto di assegnare al Vecchio Continente il ruolo di “campione della regolazione”, lasciando serenamente ad altre regioni il compito di innovare e costruire ricchezza. Noi europei siamo sicuramente i custodi di una ricetta per il progresso che ha favorito uguaglianza e inclusione attraverso l’affermazione dei diritti ma quei diritti rischiano di diventare lettera morta se perdiamo terreno rispetto ai concorrenti internazionali.
Forse è giunto il momento di rivedere la strategia e di recuperare l’ambizione di creare ricchezza attraverso la libertà di innovare.