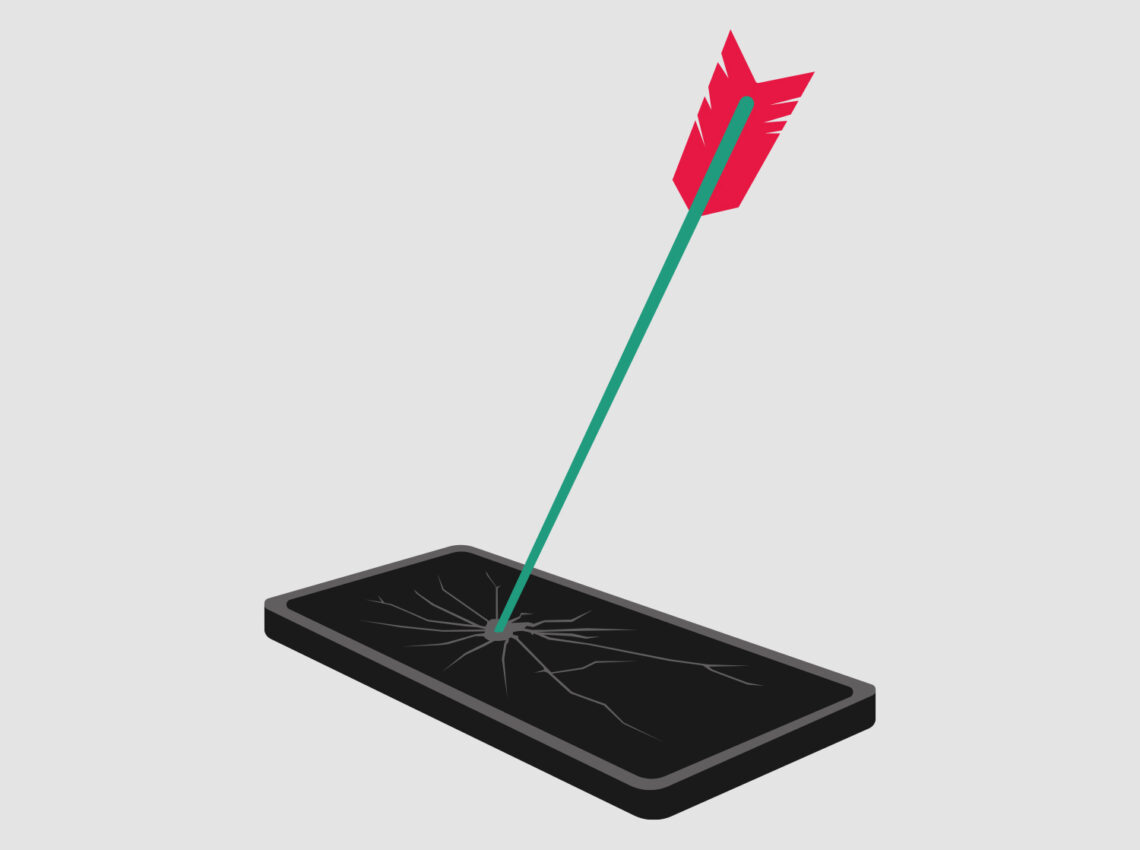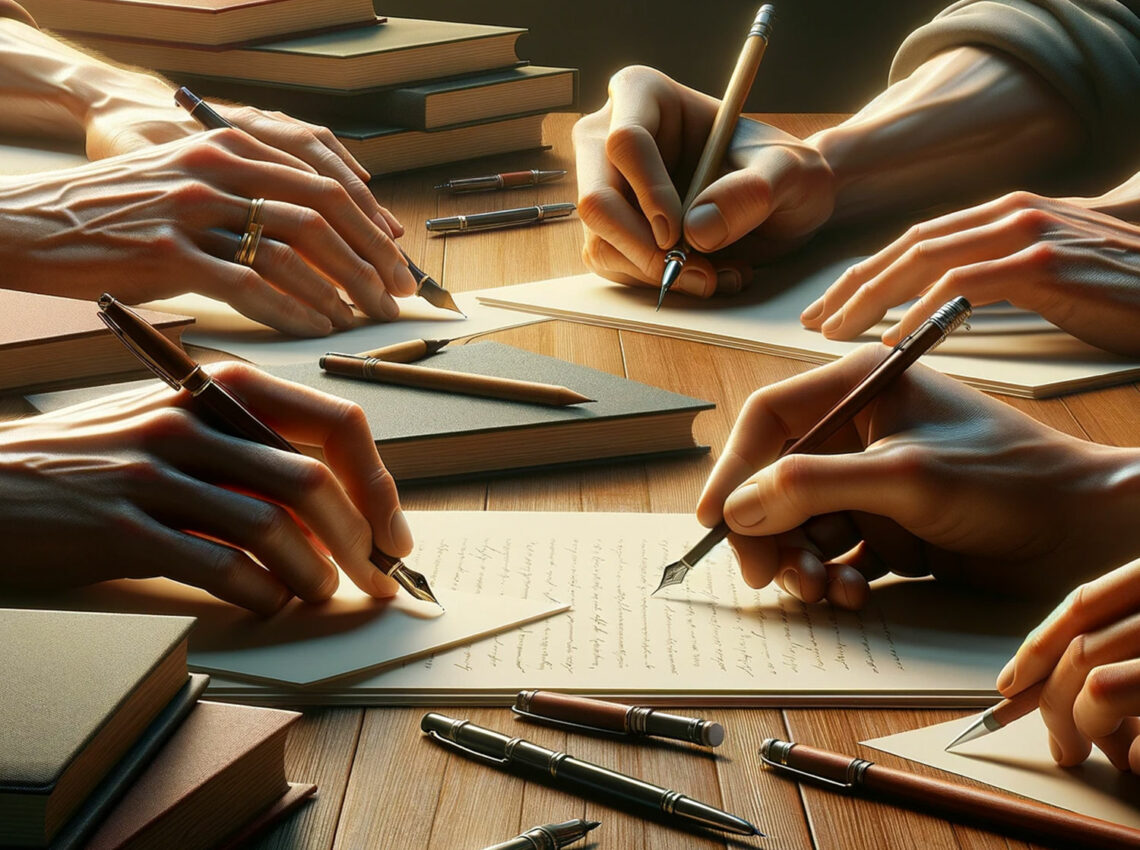Per un’Italia più produttiva la politica riacquisti centralità
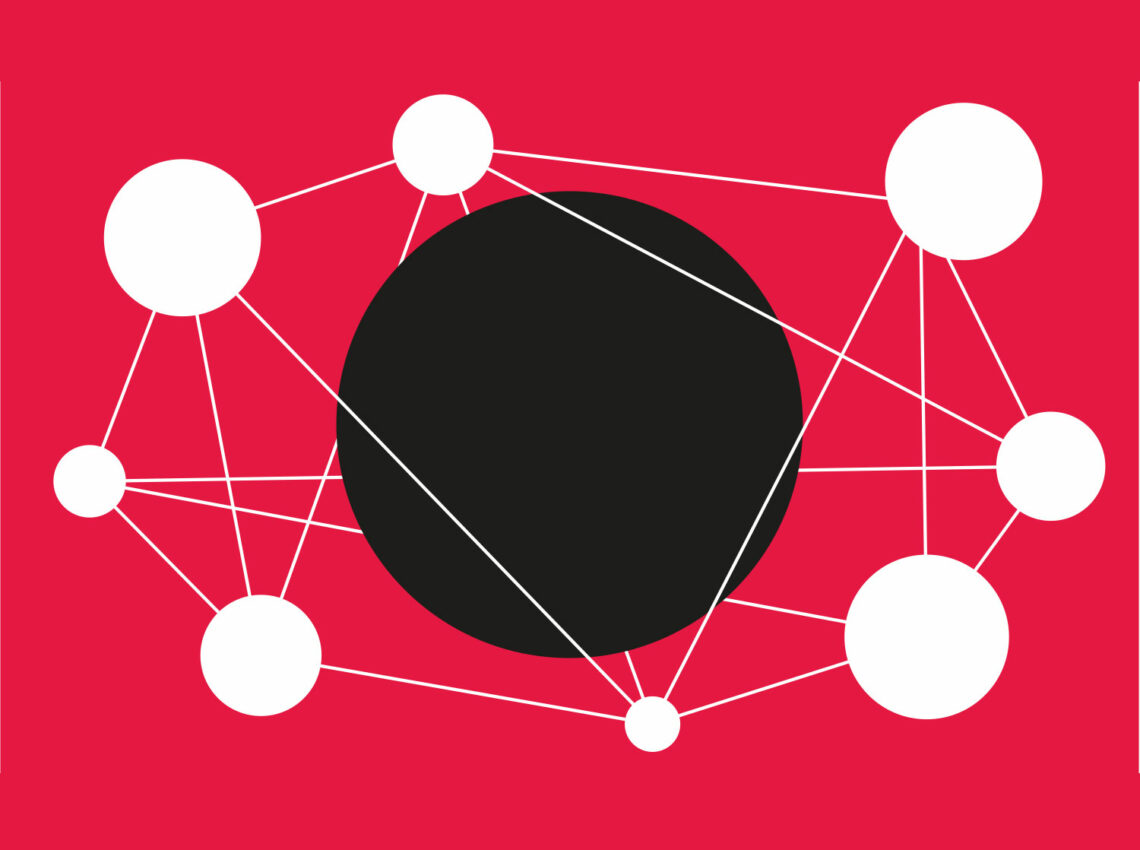
Mi è capitato tra le mani l’ultimo rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che certifica con disappunto le distanze che l’Italia non ha ancora colmato verso i 17 obiettivi delle Nazioni Unite, ormai a 7 anni dal 2030. Mi sono chiesto quali fossero le ragioni che non consentono, al nostro Paese e a differenza di altri, di prendere le distanze dai vecchi modelli, verso un futuro più efficiente, equo e leggero. La prima risposta che mi sono dato, in particolare per i temi che seguo più da vicino, che sono la transizione energetica e quella digitale, è che le vere rivoluzioni possono anche nascere in una stanza, ma necessitano di essere sostenute dalle gambe delle persone.
La prima resistenza infatti è di natura culturale, conservativa, direi semplicemente umana.
È capitato infatti che in questi anni di seconda e (forse) terza Repubblica, la Politica abbia abdicato al suo ruolo di interprete e guida, e sia diventata follower, prima dei vecchi sistemi sondaggistici, adesso anche dei trend misurabili online. Da un sistema che prima era top down, dove il pensiero era elaborato in appositi momenti di discussione, si è passati ad uno bottom up dell’era post ideologica. Si tratta naturalmente di un fenomeno di natura globale, che però in Italia poggiava su un sistema particolarmente instabile.
Come ha ricordato il Presidente Meloni infatti, in 75 anni dalla nascita della Repubblica abbiamo avuto l’avvicendamento di 31 Presidenti del Consiglio e 68 Governi, cioè in media un Presidente del Consiglio ogni 2 anni e mezzo, e un Governo nuovo ogni anno e qualche mese.
La vera rivoluzione può nascere in una stanza, ma deve essere sostenuta dalle gambe delle persone. La prima resistenza è culturale, conservativa e del tutto umana.
Il combinato disposto tra questa precarietà e leggi elettorali che, abbandonando le preferenze, hanno spinto i candidati a concentrare le loro attenzioni su chi componeva le liste e non sui rappresentati, ha fatto sì che gli sforzi dovessero concentrarsi più sul mantenimento del consenso – interno ed esterno – che sul governo effettivo del Paese. Il corpo elettorale non è stato informato e guidato, è stato assecondato nei suoi bias di conferma, cavalcandone anche le comprensibili paure, ai fini della spartizione del consenso.
Tutto ciò in un periodo storico particolarmente complesso: dalla crisi economica del 2008, passando per la pandemia, la guerra in Ucraina, e le accese tensioni in Cisgiordania, poi la paura dell’intelligenza artificiale, del 5G e in aggiunta persino l’ecoansia. Una fase che alcuni definiscono di “permacrisi”.
Le resistenze territoriali hanno contribuito alla conservazione dello status quo, alla frammentazione di più Italie, dove le disuguaglianze tra centri e periferie in termini di opportunità sono diffuse a macchia di leopardo, ma che trovano ancora più divari nel suo Meridione. Un Paese che vede la punta dell’iceberg quando discute di studenti che non riescono a pagare gli affitti, di giovani che emigrano in mercati che li valorizzano di più, che non hanno la forza o la voglia di mettere su famiglia, perché sanno che agli sforzi messi in campo non sempre corrisponde una conseguente gratificazione. Un Paese così è un Paese che ha fermato il suo ascensore sociale, che ha bloccato la sua produttività, che non discute di salari per ipocrita pudicizia, quando in realtà la soluzione è tutta lì: nello sviluppo economico, che può essere sostenibile sia socialmente che ambientalmente. Servono allora infrastrutture fisiche e digitali, per essere competitivi in un mercato complesso, che vede in atto l’intenso tentativo di spostare l’ordine. mondiale da occidente a oriente.
Ma non solo ne vanno realizzate di nuove, vanno anche conservati e difesi alcuni asset esistenti, che ci hanno reso leader in particolari mercati, tenendo certo sempre a mente gli obiettivi ambientali, ma allo stesso tempo non rendendo le transizioni ostili al benessere economico delle persone. Forse è per questo che, in assenza di partiti che in maniera capillare potessero diffondere informazione e confronto, il mondo produttivo e industriale ha capito l’importanza dei think tank, del dibattito pubblico locale, della comunicazione mirata dei micro influencer. Ed è per questo che, anche nel mondo del Public Affairs, si è compreso che non è più immaginabile una netta separazione tra il lobbying nel suo senso più puro e tecnico, e l’advocacy, che si realizza nei suoi vari canali di comunicazione, soprattutto online.
La politica deve essere cosciente però di un rischio, un Paese cinico e disilluso, anzi deluso, è un Paese che smette di sperare e quindi di correre (non a caso in Italia il numero di giovani Neet è di 1,7 milioni, cioè 1 su 5 tra i 15 e i 29 anni) ed è un Paese che non percepisce l’utilità della politica stessa, mettendo in discussione persino la forma democratica. Mi ha colpito lo studio condotto dall’IE University, secondo il quale il 59% degli italiani sarebbe favorevole a sostituire deputati e senatori con le nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale. Come si fa allora a restituire centralità alla politica? Con gli atti di coraggio.
Per dare dignità alla politica non basta rappresentare la pancia degli elettori, ma occorre una sintesi tra interessi, supportata dalla somma di informazioni disponibili, per prendere decisioni rispettose del programma elettorale
A chi lavora nel campo delle relazioni istituzionali sarà spesso capitato di interloquire con qualche parlamentare che, d’accordo con le nostre tesi, avrebbe poi dovuto confrontarsi con la linea del gruppo, che spesso non è generata da valori programmatici da rispettare, bensì dal bilanciamento di pro e contro che derivano dalla misurazione del consenso. Immaginate quanto questo meccanismo possa comprimere l’art. 67 della nostra Costituzione, che libera i parlamentari nell’esercizio delle funzioni da qualsiasi vincolo di mandato. Eppure una decisione presa in assenza di corrette informazioni porta a scelte fallaci. È per questo che per dare dignità alla politica non basta rappresentare la pancia dei propri elettori, ma va realizzata una sintesi tra i diversi interessi che si rappresentano, supportata dalla somma di informazioni alle quali si può accedere da quella posizione, per poi tirare le fila e prendere una decisione anche apparentemente in contrasto con il sentiment del momento, ma rispettosa del programma elettorale per il quale si è stati eletti. Le idee cambiano per definizione e chi si comporta da leader troverà followers disposti a seguirlo.
Per questo è possibile che con una riforma costituzionale che offra maggiore stabilità al sistema si possa stimolare un maggiore coraggio della classe parlamentare, e una sua maggiore centralità. Dobbiamo farlo per difendere il modello democratico, restituire fiducia ai cittadini, e incanalare il Paese sui binari dello sviluppo sostenibile. Con fiducia, ottimismo e senza paura. Perché come scriveva Holderlin “lì dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva”.