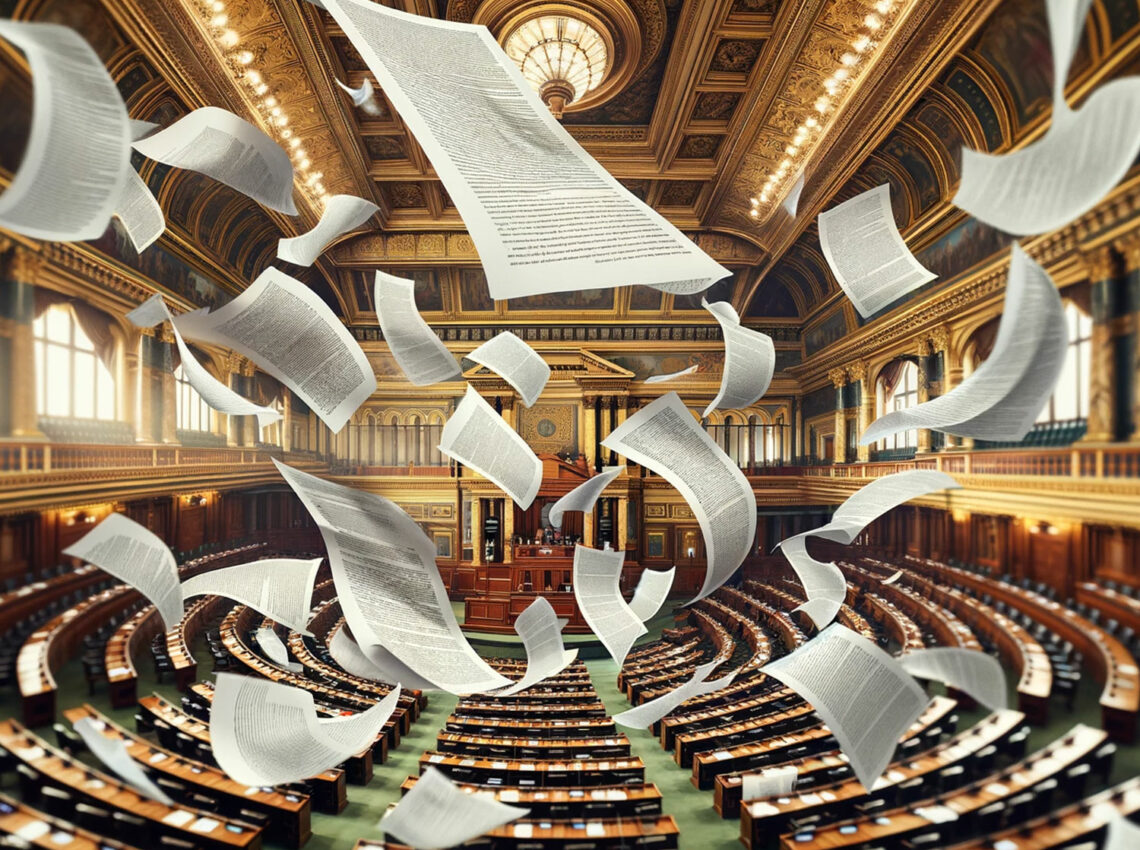Storie che aprono porte: riflessioni sul diritto al voto

Le storie che funzionano sono quelle che aprono porte. Che si tratti di letteratura, cinema, tv, racconti reali o inventati, quelle che funzionano, spingono sempre ad andare a cercare qualcos’altro.
Funziona così per la prima pellicola diretta da Paola Cortellesi “C’e ancora domani” che in queste giornate cupe di porte ne apre tantissime, spingendo lo spettatore a recuperare un ricordo, un racconto di famiglia, una foto. Nei cassetti di casa o della propria memoria. Se è vero che nulla accade per caso, non a caso forse la pellicola arriva come uno schiaffo in faccia, nel momento in cui il nostro Paese è ripiegato su sé stesso, scosso dal caso di Giulia Cecchettin, vittima come Delia, la protagonista del Film, delle botte, dei maltrattamenti, delle umiliazioni dell’uomo che le stava accanto. Come davanti ad uno specchio l’Italia si riconosce tristemente, 77 anni dopo, in quell’Italia che scorre in bianco e nero sulla pellicola; si riconosce in quelle botte, in quei silenzi di chi oggi esattamente come allora, subisce e non denuncia.
Ed è su questo che la politica prova a cercare un terreno comune, per arginare un fenomeno in piena che ha già portato, da inizio anno, alla morte di 102 donne in Italia. Un tema su cui lavorare insieme dice la Premier Giorgia Meloni in Aula, dopo un confronto con la Segretaria Dem Elly Schlein. Le due leader, agli opposti del potere, in molti vorrebbero vederle sfilare insieme, in una grande piazza di valori condivisi nonostante le differenze. Una piazza che a due donne consegni un unico megafono contro la violenza, un terreno comune che a questo punto diventa doveroso trovare.
Quel terreno comune è diventato il ddl sulla violenza di genere votato all’unanimità in Senato con l’approvazione di due ordini del giorno del Pd che, combinati a uno di maggioranza, accelerano i tempi per una discussione in Aula sull’introduzione di corsi antiviolenza nelle scuole. Un inizio da cui partire, lasciando fuori dalla porta la ricerca del colpevole, l’educazione che manca, il rumore delle polemiche scomposte e delle strumentalizzazioni che le proposte di una sola parte si trascinano inevitabilmente dietro.
La politica si interroga sulla prevenzione, sull’educazione e su chi debba farsene subito carico. La famiglia, la scuola.
Si pensa all’introduzione di un progetto formativo anti femminicidi, all’educazione sessuale e affettiva da insegnare in classe. Al significato delle parole “rispetto e relazione”. Ma come si è arrivati fin qui? Come siamo arrivati al punto di dover cercare una legge che imponga e insegni il rispetto della donna? Ammesso che una legge ne abbia il potere. Martedì 21 novembre tutti gli studenti delle scuole italiane, alle 11 del mattino, hanno osservato un minuto di silenzio, o di rumore, per Giulia e per tutte le donne vittime di violenza.
“Un minuto di silenzio non è necessario” aveva detto Elena, la sorella di Giulia che al Paese e alle Istituzioni chiede di prendere questa vicenda da esempio e trasformarla in potere. Ha usato proprio questa parola, potere.
Un potere contro chi picchia, umilia, stupra.
Un potere che protegga, chiede Elena, tutte le ragazze del futuro e del presente. A tutte loro Gino Cecchettin, il padre di Giulia, chiede di avere coraggio, di guardare con grande attenzione dentro ad ogni loro relazione. Di condividere con le proprie famiglie ogni dubbio per avere salva la vita.
Nel film di Cortellesi, Delia si “salva” nella cabina elettorale grazie al diritto di scelta finalmente conquistato. Il diritto di voto in qualche modo la libera dall’invisibilità, le dà un potere, la parola usata da Elena Cecchettin come antidoto all’umiliazione e alla violenza. Un diritto che salva, di cui oggi si è perso il significato.
Le storie che funzionano sono quelle che aprono porte, dicevamo. “C’è ancora domani” apre la porta della memoria che torna ad un articolo datato 2 Giugno 1946 dal titolo: Senza rossetto nella cabina elettorale. Il Corriere della Sera saluta cosi la conquista del diritto al voto per le donne e il loro primo ingresso nei seggi italiani.
Siccome la scheda deve essere incollata e non deve avere alcun segno di riconoscimento, le donne nell’umettare con le labbra il lembo da incollare potrebbero, senza volerlo, lasciarvi un po’ di rossetto e in questo caso rendere nullo il loro voto. Dunque, il rossetto lo si porti con sé, per ravvivare le labbra fuori dal seggio.
Comunicazioni di servizio per un debutto acqua e sapone istituzionalmente corretto. Altra porta: l’affluenza al voto il 2 e 3 Giugno 1946 in cui a tutti gli italiani viene chiesto di scegliere tra monarchia e repubblica e di eleggere l’Assemblea Costituente cui sarebbe stato affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale. Lo fece l’89,8%. Il 18 Aprile 1948, nelle prime elezioni politiche dall’entrata in vigore della Costituzione, ai seggi si presentò il 92% degli aventi diritto in un boom che prosegui via via negli anni, elezione dopo elezione, dal 1948 fino al 1979 con una affluenza sempre sopra al 90% e un picco del 93,39% registrato alle politiche del 20 Giugno 1976.
Sono lontani, lontanissimi gli anni dello spacchettamento del dato e della ricerca delle cause dell’astensionismo, il sole del week end, il ponte, il divario sempre più ampio tra nord e sud. Sono gli anni del piombo, degli opposti estremismi, del senso profondo di appartenenza alla politica, ai suoi valori e ai partiti. Gli anni della passione e dei manifesti senza i volti ma con i simboli, che bastano a far battere il cuore degli elettori. Gli anni dei confronti infiniti sulle idee e sulla politica argomento di dibattito e confronto ovunque, nelle case, nelle scuole, nelle piazze, nei bar. “Al bar Casablanca, con una gauloise, la nikon, gli occhiali – come cantava Gaber – E sopra una sedia i titoli rossi dei nostri giornali. Blue jeans scoloriti, la barba sporcata da un po’ di gelato. Parliamo, parliamo, di rivoluzione, di proletariato”. Fin qui l’astensionismo non rappresenta un problema. Non esiste ancora come fenomeno. Inizia a diventarlo più tardi, con il primo calo significativo nei primi anni 80 che porterà al tonfo dei nostri giorni.
I partiti sono in crisi e non è sufficiente richiamare l’attenzione di elettori via via sempre più distratti e disattenti con un tentativo, a volte goffo, di personalizzazione del partito, utile semmai a moltiplicare la frammentazione politica e la polarizzazione ideologica.
I dati sconfortanti di oggi li conosciamo. Le nostre analisi post voto iniziano quasi sempre con “ha votato 1 italiano su 3” o “metà Paese ha scelto di far scegliere ad altri”. Alle ultime elezioni del 2022 l’affluenza si è fermata al 63,9%, con il dato più basso dell’intera storia Repubblicana in termini di elezioni politiche e il 9% in meno rispetto alle elezioni precedenti.
L’Istat certifica ciclicamente che la fiducia degli italiani nei partiti continua a calare, che lo scollamento tra il palazzo e la piazza è sempre più profondo, che manca l’orizzonte a lungo termine. Ora il ritmo lo danno le elezioni Europee, tutti gli sforzi sono su questo appuntamento e di conseguenza gli elettori seguono quel ritmo, si spostano come ballerini da un partito all’altro, assecondando il sentimento del momento e lo slogan che in quel momento convince di più.
Sarebbe bello se le riflessioni portassero a qualcosa di concreto. Al recupero, ad esempio, dell’importanza del diritto al voto. Alla consapevolezza di quanto l’espressione di quel diritto sia sinonimo di libertà. Ieri come oggi.
Proprio come cantava Gaber:
La libertà non è star sopra un albero
Non è neanche il volo di un moscone
La libertà non è uno spazio libero
Libertà è partecipazione.