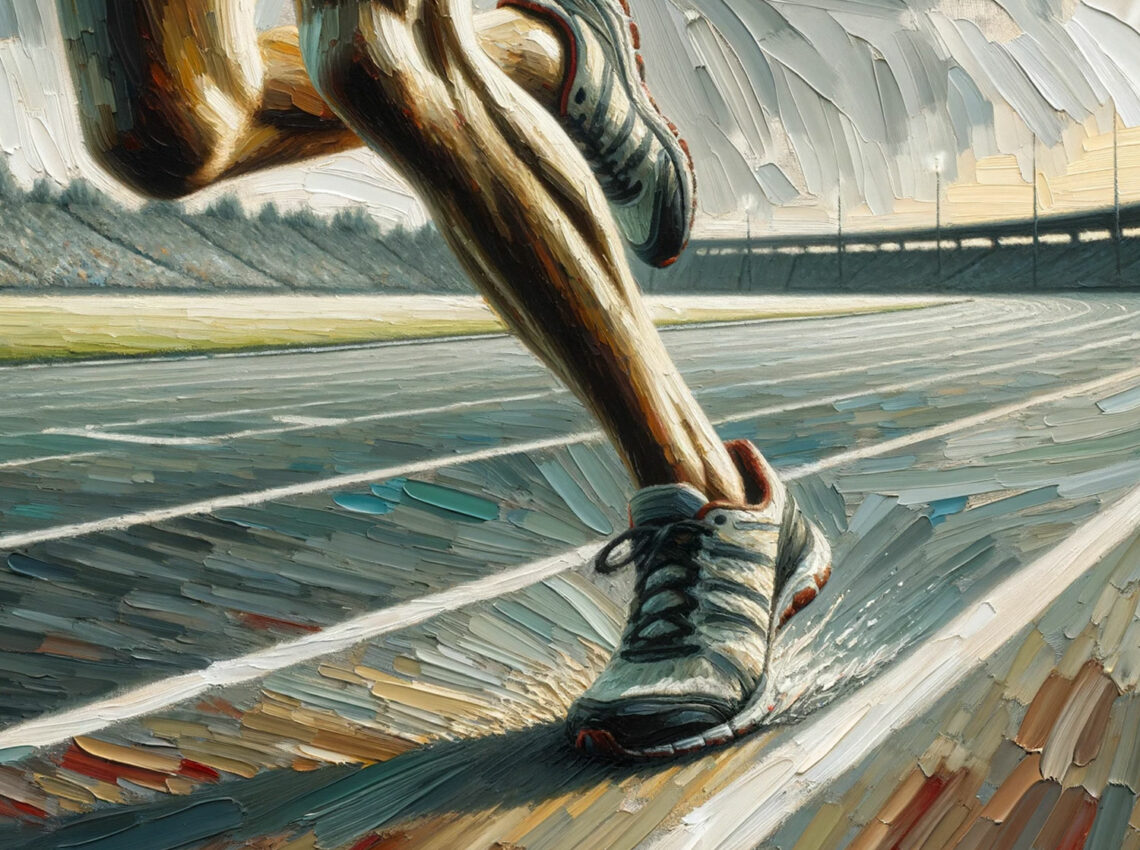Su innovazione servono più risorse ma soprattutto governance
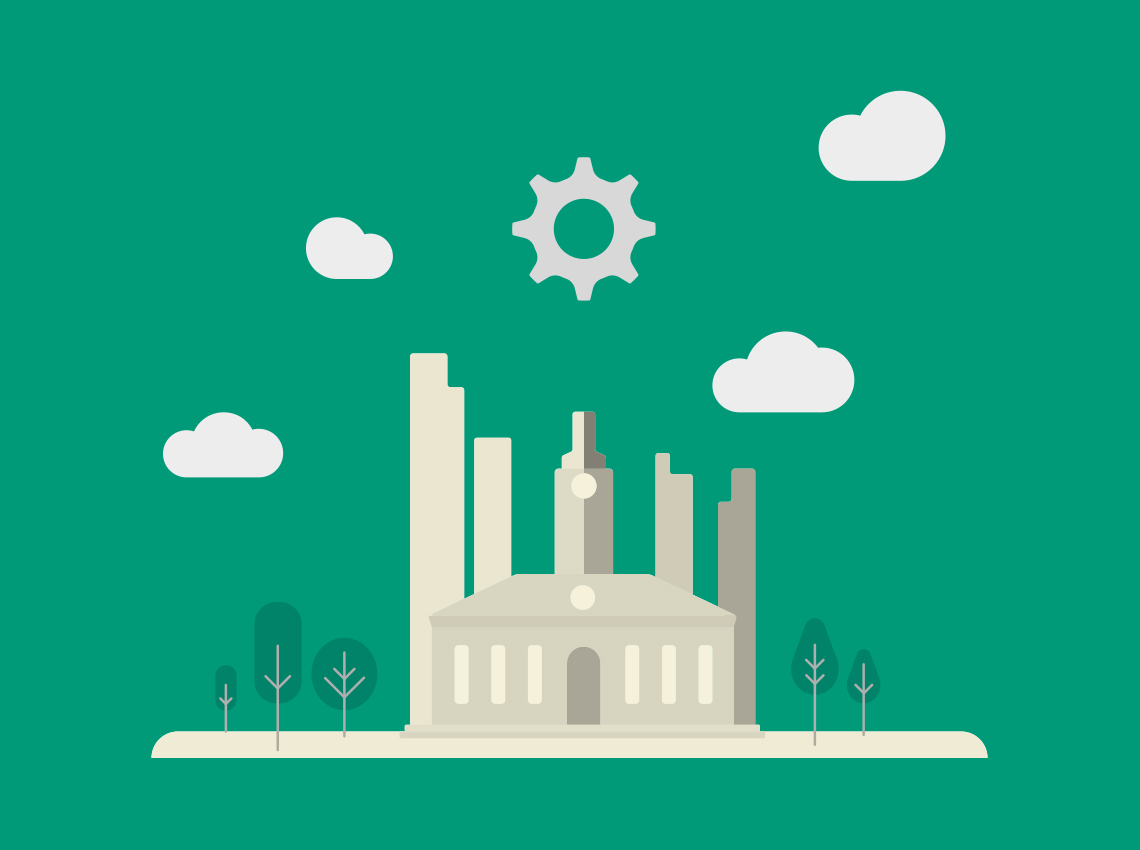
Nonostante I progressi maturati negli ultimi cinque anni, l’Italia è ancora parecchio indietro nella propria digitalizzazione rispetto agli altri Paesi Europei. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’indice DESI (Digitale Economy and Society Index), che ogni anno la Commissione Europea elabora per monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri nel settore digitale, l’Italia si posiziona diciottesima tra i 27 membri, dietro a tutte le grandi economie del continente, e leggermente sotto la media europea.
Come mostra il grafico, i parametri su cui siamo più deboli sono lo sviluppo del capitale umano e la presenza di servizi pubblici digitali. Si tratta di due indicatori che già di per sé spiegano buona parte dei problemi di competitività del nostro Paese, dall’alta disoccupazione giovanile alla bassa produttività multifattoriale che condanna molte delle nostre aziende.
Le risorse disponibili e i ritardi
Non è un caso se circa un quarto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia, che è anche quello economicamente più importante dell’intera Unione europea, è destinato alla transizione digitale (circa 48 miliardi euro).
Tra le milestone si annoverano diversi importanti interventi proprio sui servizi pubblici digitali come la riforma “Cloud first e interoperabilità”, che introduce anche incentivi e obblighi per l’adozione del cloud da parte delle pubbliche amministrazioni, i piani “scuole connesse” e “sanità connessa”, il piano “Italia a 1 Giga” e “Italia 5G”. Purtroppo, non tutti i cantieri stanno avanzando come previsto, come ho avuto modo di verificare personalmente anche con alcune interrogazioni sul tema, e molte risorse previste dal nostro PNRR rischiano di essere messe in discussione.
A tal proposito non sembra aver aiutato la scelta della Presidente Meloni di non aver istituito un ministero dedicato alla transizione digitale, come dimostrano le frequenti divergenze di vedute e mancanza di chiarezza di competenze e deleghe tra il Ministero delle Imprese Urso e il Sottosegretario Butti, delegato dalla Presidenza del Consiglio alla transizione digitale. D’altronde, le sfide che ci attendono sono tante, non da ultimo una serie di trasposizioni di normative europee di primaria importanza quali NIS2, AI Act, Cyber resilience Act, DSA e DMA solo per citare le più famose.
Una nuova governance e gli interventi prioritari
Per recuperare il tempo perso è innanzitutto fondamentale riformare i criteri di governance politica dell’innovazione. Come già spiegato, in un contesto in cui transizione blu e verde sono la sfida su cui si gioca il futuro del mondo intero, la mancanza di una figura deputata a coordinare tutti i progetti di digitalizzazione del Paese rischia di essere un handicap fatale. Perché se da un lato manca un “capo”, dall’altro la complessità esplode e le autorità che si occupano di digitale crescono in numero e in competenze; tra tutte l’Agenzia per la Cybersecurity Nazionale (ACN), e l’istituzione probabile di una nuova agenzia deputata all’implementazione dell’AI Act europeo.
Una migliore governance inoltre consentirebbe di porre fine alla tipica attitudine italiana a dilazionare in infiniti rivoli le risorse, come dimostra anche il PNRR per quanto riguarda i centri di trasferimento tecnologico (al momento 51 per l’attuazione del PNRR), formazione e ricerca (si sono aggiunti 5 nuovi centri nazionali) e innovazione (si stanno ancora implementando e cercando di far funzionare i competence centres e Digital Innovation Hubs previsti da industria 4.0). Perché, anche se vero che avere centri d’innovazione sul territorio vicini alle imprese può essere prezioso, non avendo risorse infinite è sicuramente meglio concentrarle in un numero finito di progetti assicurandosi che non restino solo sulla carta o, peggio, finiscano per costruire cattedrali nel deserto.
Risolto questo aspetto, a mio avviso preliminare, ci sono poi le questioni di merito e i progetti che dovrebbero essere prioritari, partendo dall’infrastruttura.
Grande priorità, dunque, a Italia 1 Giga e Italia 5G, possibilmente garantendo degli alti standard qualitativi del materiale utilizzato (sulla tipologia di fibra da impiegare il Mimit deve ancora fornire chiarimenti). Servono poi misure abilitanti per lo sviluppo di nuovi datacenter, infrastrutture strategiche ma energivore, che ad oggi non godono di nessun tipo di garanzia né di iter specifici per la loro creazione, con grande frustrazione degli amministratori locali che – qualora scelgano di ospitarne uno sul proprio territorio – finiscono per essere rimbalzati tra ministeri e incertezze normative (ci sto lavorando in commissione con un disegno di legge che spero di poter incardinare in discussione prima della fine della legislatura).
Maggiore decisione da parte del Governo servirebbe anche sul fronte della cybersicurezza. Come ho scritto nella mia risoluzione depositata circa un anno fa in IX Commissione, infatti, la componente 2 della missione 1 «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede per la cybersicurezza un investimento di soli 0,62 miliardi di euro (pari allo 0,2 per cento del piano). Numeri chiaramente insufficienti, visto che il Ddl sulla cybersicurezza in discussione ora in I Commissione, che sto seguendo in sostituzione della mia collega, non mette sul piatto altre risorse pur prevedendo nuovi obblighi per le pubbliche amministrazioni, tra i quali la nomina di un responsabile per la cibersicurezza (da individuare tra le risorse umane in essere) e deroghe a prezzi minimi in caso di appalti dedicati alla cybersecurity – entrambe misure giuste ma sicuramente non a costo zero.
Ma le risorse sono uno dei tanti problemi, e, infatti, l’altra grande questione aperta in Italia è quella delle competenze. In un Paese in cui per circa il 50% delle posizioni scoperte le aziende faticano a trovare personale, soprattutto per mancanza di personale qualificato o preparazione inadeguata (dati Unioncamere-Anpal gennaio 2023), non si può prescindere dalla formazione. Dopo aver archiviato un quinquennio di reddito di cittadinanza elargito senza richiedere ai percettori nessun tipo di impegno verso il reskilling, sembra che il nuovo Governo non abbia ancora trovato una quadra per invertire i trend della disoccupazione e della “mala occupazione”.
A mio avviso è necessario investire maggior risorse sulla formazione e soprattutto negli ITS, la cui riforma appena avviata speriamo possa dare da subito risultati positivi. Bisogna farlo a tutti i livelli, per esempio in consiglio comunale a Milano ho proposto un avvicinamento tra un ITS locale e la Pubblica Amministrazione cittadina attraverso un corso-concorso dedicato a figure specializzate nella cybersecurity, sul modello di quanto già fatto a Bologna. Credo sia anche necessario fare tutto il possibile per portare nel nostro Paese talenti freschi dall’estero. E per questo temo non bastino i bonus; a tal proposito in questi mesi ho sollecitato a più riprese Ministero dell’Università e quello dell’Interno su due questioni che ritengo di fondamentale importanza: nuove modalità semplificate per il riconoscimento dei titoli di laurea e dottorato ottenuti all’estero e la pubblicazione delle linee guida per il riconoscimento del visto a chi sceglie l’Italia come luogo per trasferirsi lavorando in remoto – i cosiddetti nomadi digitali (queste ultime pubblicate finalmente a inizio marzo).
In generale quello che dovrebbe fare chi governa, a mio avviso, sarebbe mostrarsi aperto alla mobilità e al cambiamento, mettendosi all’ascolto di tutti coloro che cercano nuovi modi per portare valore alla nostra economia. Un esempio su tutti è quello degli “influencer”, il cui settore secondo alcuni studi vale già oggi oltre 1 miliardo di euro ed è in grado di condizionare il successo anche internazionale di molte imprese italiane.
Questi sono solo alcuni dei cantieri su cui credo sia necessario procedere in modo diverso. Non sono entrata nel merito degli incentivi per le tecnologie cosiddette 4.0 o 5.0, fondamentali per la produttività e l’innovazione aziendale. Noi di Azione lo diciamo da sempre, su digitalizzazione – ma anche tecnologie per la decarbonizzazione – dovrebbero essere convogliate la maggior parte delle risorse destinate alla politica industriale.