Un anno di Parlamento della XIX legislatura: tante prime volte e alcune costanti

Il Parlamento della XIX legislatura ha da poco compiuto il suo primo anno di vita e può essere utile – nel primo numero di questa Rivista – tracciare un primo, necessariamente provvisorio, bilancio, soprattutto guardando alle prime volte e ad alcune costanti.
Si tratta, infatti, di un Parlamento per più versi “nuovo”, derivante da quelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 che, a loro volta, sono state uniche nel loro genere.
Oltre a svolgersi in un periodo caratterizzato dalla recrudescenza di una pandemia mondiale, nel pieno di una crisi energetica e di una guerra alle porte dell’Europa, sono state le prime elezioni dell’Italia repubblicana in cui – per effetto delle leggi costituzionali n. 1/2020 e n. 1/2021 – si è votato per eleggere un Parlamento “a ranghi ridotti” (per via della riduzione del numero dei parlamentari: si è passati da 630 deputati e 315 a senatori a, rispettivamente, 400 e 200) e nelle quali sono diventati parte del corpo elettorale, anche per il Senato della Repubblica, i cittadini diciottenni, parificando in tal modo l’elettorato attivo delle due Camere.
Vi sono state alcune peculiarità per quanto riguarda la legge elettorale e la strutturazione dell’offerta politica. Da una parte, al Senato, il combinato disposto tra la riduzione del numero dei parlamentari e la legge elettorale vigente ha sottorappresentato le piccole regioni e ha svantaggiato le formazioni minori, perché i seggi proporzionali assegnati in diverse regioni sono stati pochi e questo ha reso il sistema proporzionale un po’ meno proporzionale. Dall’altra parte, un ruolo del tutto centrale è stato giocato dal sistema elettorale “misto”, la legge n. 165 del 2017 (il c.d. “Rosatellum”), che ha trasformato una maggioranza relativa di voti in maggioranza assoluta di seggi in entrambi i rami del Parlamento, senza riuscire, tuttavia, a spingere i (più rilevanti) partiti all’infuori della coalizione di centrodestra ad allearsi prima del voto che, in tal modo, è stato asimmetrico: con una coalizione da una parte dello schieramento e con una coalizione (molto ridotta) sull’altro versante – creando quello che è stato chiamato “bipolarismo asimmetrico”.
Inoltre, per la prima volta nella storia della Repubblica si è votato in autunno, dopo un’atipica campagna elettorale estiva. Per la prima volta è stata una donna a diventare Presidente del Consiglio, dopo la forte affermazione del suo partito alle elezioni del 25 settembre 2022. Ma in quelle elezioni si è anche confermata una tendenza ormai in atto da trent’anni, che ha visto la costante ascesa dell’astensionismo: nonostante la legge costituzionale del 2021 già richiamata abbia ampliato il diritto di elettorato attivo al Senato, l’astensionismo ha continuato a crescere, arrivando al 36%.
La riduzione del numero dei parlamentari, a sua volta, ha creato la necessità di intervenire sui regolamenti parlamentari, per adeguarli almeno ai nuovi numeri di deputati e senatori. Mentre al Senato si è proceduto a una (corposa) riforma del regolamento nell’estate del 2022, a distanza di soli cinque anni dall’ultimo rilevante intervento, la Camera ha atteso l’inizio della nuova legislatura per modificare il proprio regolamento, intervenendo non solo in ritardo rispetto all’altro ramo del Parlamento, ma limitando le modifiche alla revisione delle soglie numeriche (peraltro, alcune parti della riforma del regolamento Camera saranno operative solo a partire dalla prossima legislatura).
La riforma del regolamento del Senato ha insistito soprattutto sull’adeguamento dei quorum, sulle regole per la costituzione dei gruppi parlamentari, sul numero delle commissioni permanenti, nonché su una serie di regole per evitare – o, quantomeno, limitare – il transfughismo parlamentare, tradendo una particolare “ossessione” per tale fenomeno.
La Camera dei deputati, al contrario, si è limitata a un intervento minimale e, quindi, le due Camere hanno vissuto il primo anno di legislatura con una vistosa asimmetria nei rispettivi regolamenti parlamentari. Asimmetria che, peraltro, si situa proprio in due settori cruciali della dinamica parlamentare: i gruppi e le commissioni, che sono le vere architravi dei lavori dei Parlamenti moderni.
Se le regole sui gruppi non hanno sinora causato evidenti divergenze – anche a causa dell’interpretazione che ne è stata data al Senato –, considerando che vi sono attualmente otto gruppi (più il gruppo misto) in entrambe le Camere, lo stesso non può dirsi per le asimmetrie in tema di commissioni permanenti. Al Senato, infatti, nel nuovo regolamento – per adeguarsi al minor numero di senatori – si è diminuito il numero delle commissioni permanenti, che da 14 sono passate a 10, con alcuni accorpamenti nelle funzioni. Alla Camera, invece, sono rimaste 14 commissioni, come se nell’altro ramo del Parlamento nulla fosse successo. Tale divergenza esplica effetti gravi nella forma di governo, favorendo ad esempio una diversa aggregazione degli interessi tra le due Camere, con esiti nefasti e piuttosto paradossali, proprio nel momento in cui, come si ricordava, l’elettorato delle due Camere è stato omogeneizzato. Sempre in tema di commissioni si deve segnalare che le Camere non hanno brillato per efficienza in alcuni ambiti: si pensi, soprattutto, alla ritardata partenza delle commissioni bicamerali: si tratta di ritardi che possono ascriversi a una questione di equilibri politici, ma che non hanno offerto un bel segnale, soprattutto considerando che alcune di tali commissioni vertono su temi del tutto cruciali.
Quanto all’attività delle Camere, i primi 12 mesi della XIX legislatura non hanno segnato una grossa discontinuità nel procedimento legislativo. In tale ambito, la pandemia ha aggravato e consolidato l’utilizzo di una serie di prassi, nell’ambito dell’iter legis, caratterizzate dal predominio del Governo in Parlamento. Soprattutto tramite l’uso della decretazione d’urgenza, l’Esecutivo non solo ha continuato a ingolfare i lavori parlamentari, ma nel corso della conversione in legge sono ormai normalmente utilizzati alcuni strumenti, quali la posizione della questione di fiducia sui maxi-emendamenti, i decreti-legge c.d. “a perdere” (o “minotauro”), la disomogeneità dei decreti-legge e delle leggi di conversione, l’abrogazione o la modifica esplicita ad opera di un decreto-legge di norme contenute in un altro decreto-legge ancora in corso di conversione, il monocameralismo di fatto (o alternato). A questi si può aggiungere il tempo che il Governo impiega per esprimere i pareri sugli emendamenti parlamentari, comprimendo ancor di più il ritmo dei lavori, trasformando il monocameralismo di fatto in un vero e proprio “monosedismo”, considerando che solo la commissione di merito della prima Camera in cui giunge il provvedimento è ormai capace di esaminarlo per davvero. Insomma, lo spazio parlamentare della funzione legislativa sembra ridursi essenzialmente nell’attività emendativa ai decreti-legge del Governo, sebbene ripetuti richiami del Presidente della Repubblica abbiano incitato le Camere a non inserire contenuti disomogenei nell’ambito dei procedimenti di conversione.
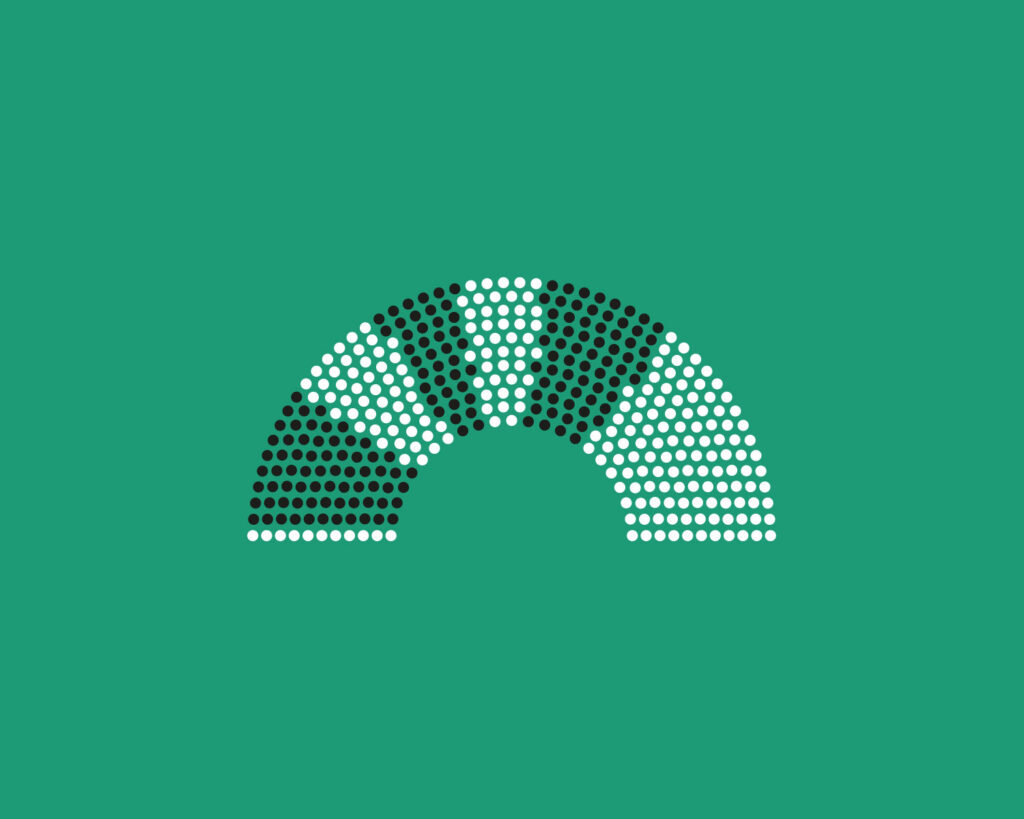
Allo stesso tempo, la tendenza a concentrare in commissione buona parte dell’iter legislativo appare attenuato da altre vicende che si sono verificate in questo inizio di XIX legislatura. Si pensi, ad esempio, alla rimessione in Aula – per la prima volta da quando tali procedure sono state introdotte nell’ordinamento – di un’opinione motivata con la quale la XIV commissione della Camera aveva ritenuto che una proposta di direttiva UE, sulla lotta contro la corruzione, non fosse conforme al principio di sussidiarietà, sfruttando una procedura scolpita in un parere del 2010 della Giunta per il regolamento.
Se, da una parte, la possibilità di deferimento in Assemblea può essere un fattore vantaggioso per la maggioranza, specie ove ci fossero commissioni con equilibri incerti, dall’altra parte si può configurare come strumento per le opposizioni che, su questioni particolarmente delicate, hanno in tal modo una possibilità per aumentare la risonanza della posizione politica della maggioranza.
Potrebbe trattarsi, allo stesso tempo, di una tendenza contraria a quanto osservato per il procedimento legislativo: c’è da capire, nei prossimi anni, se dopo la riduzione del numero dei parlamentari si andrà consolidando una predilezione per procedimenti che non si esauriscono in commissione ma che vedono la loro conclusione in Assemblea.
Un altro segnale non incoraggiante arriva dal Parlamento nell’ambito delle procedure euro-nazionali di bilancio, in uno degli snodi cruciali del semestre europeo: ci si riferisce, in particolare, alla prima bocciatura del c.d. “scostamento di bilancio”. Per la prima volta da quando lo strumento è stato introdotto con la legge cost. n. 1 del 2012, il 27 aprile 2023 alla Camera non è stata approvata, a maggioranza assoluta, la risoluzione approvativa della Relazione con cui il Governo chiede al Parlamento di autorizzare il maggiore indebitamento.
Pur trattandosi di un “incidente”, la vicenda non solo ha fatto sorgere interessanti questioni sul piano costituzionale, ma, soprattutto, rappresenta un segnale preoccupante sulla scarsa attenzione delle Camere agli snodi fondamentali del semestre europeo, proprio in un momento in cui è all’orizzonte una decisiva riforma del Patto di stabilità e crescita e in cui l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza chiama il Parlamento (e il Governo) ad una attenzione vieppiù maggiore su tali snodi.
Insomma, il Parlamento della XIX legislatura si è mosso finora tra molte prime volte e diverse costanti, né le une né le altre sempre positive. C’è ancora tempo per consolidare prassi positive e abbandonare quelle più negative, dando crescenti segnali di vitalità, indispensabili per riequilibrare la forma di governo.






