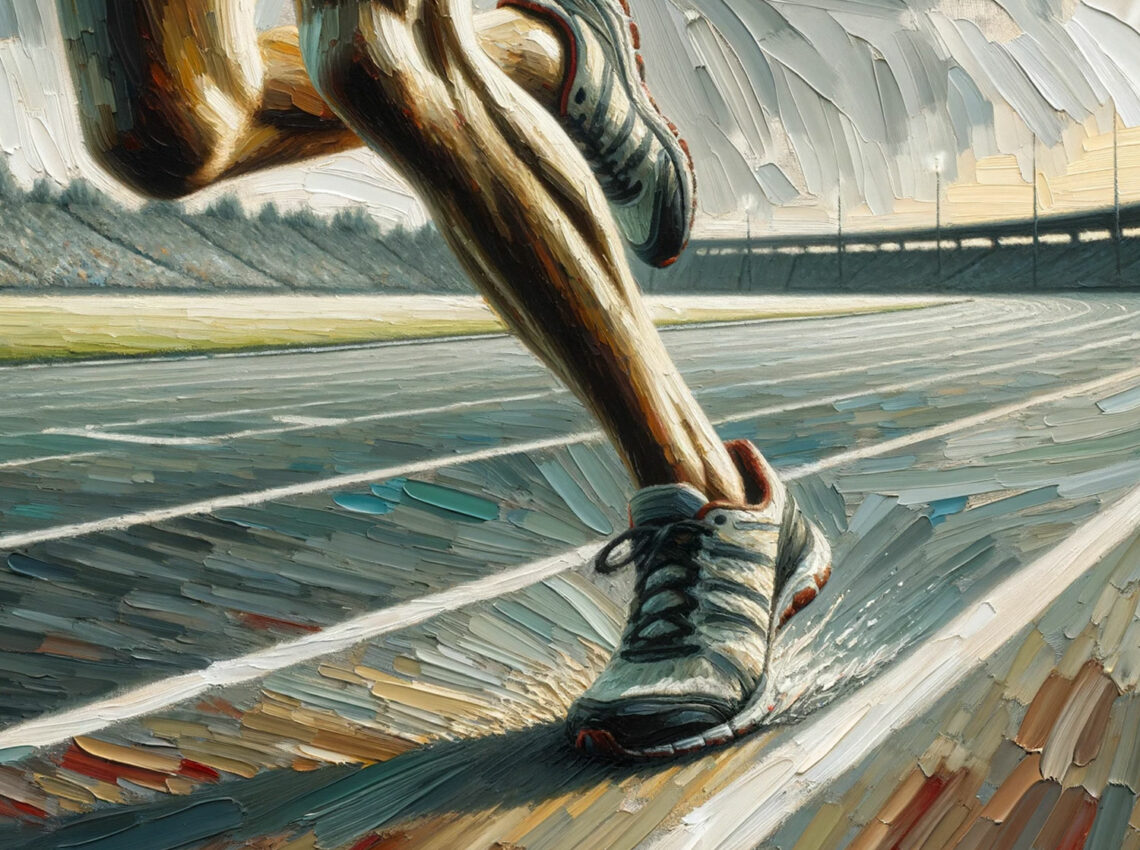Una anomalia tutta italiana: il decreto Milleproroghe

Anche per il 2024, come ormai da quasi trent’anni il Parlamento ha approvato il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”. Il testo, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, varato dal Consiglio dei ministri 30 dicembre scorso, assegnato in prima lettura in sede referente alla Camera dei Deputati nelle Commissione congiunte Affari Costituzionali e Bilancio e poi al Senato in Commissione Affari Costituzionali, è stato approvato il 21 febbraio scorso dall’Assemblea di Palazzo Madama.
Il Milleproroghe costituisce un provvedimento un po’ particolare, un unicum nel suo genere: è infatti quello in cui il governo stabilisce il prolungamento della validità di norme che stanno per scadere. Non a caso viene quasi sempre approvato a ridosso della fine dell’anno, visto che la gran parte delle misure scade di solito il 31 dicembre.
Per la sua utilità, si tratta di uno strumento adoperato da tutti i Governi, a prescindere dall’orientamento politico: Consente infatti di inserire in un unico documento tutte le norme prossime alla scadenza su cui non si è riusciti a intervenire in maniera strutturale o che sono rimaste un po’ in sospeso, anche se riguardano materie molto eterogenee tra loro.
Esso contiene due tipologie di norme – osserva Giampaolo Galli – che colpiscono particolarmente: “le norme che prevedono proroghe infinite e quelle che prevedono proroghe che potremmo definire affannose. Le prime si ripetono anno dopo anno per periodi che a volte superano il decennio…Le seconde invece prorogano termini che sono stati fissati da leggi pochi mesi prima e a volte pochi giorni prima: vengono inserite nel Milleproroghe all’ultimo minuto utile (spesso il 31 dicembre per prorogare un termine del 1° gennaio) e riflettono l’affanno dei soggetti interessati – siano essi privati o amministrazioni all’approssimarsi di una scadenza impossibile da rispettare… L’anomalia è infatti l’imprevidenza del legislatore che fissa termini irrealistici o approva norme che non possono trovare applicazione. Il Milleproroghe è dunque un rimedio a questo stato di cose; è la realtà che bussa alla porta del legislatore”.
Tra le varie e disparate misure previste quest’anno: esenzione per l’Irpef sui redditi agrari; riapertura dei termini per il pagamento delle rate della rottamazione quater; prosecuzione del rapporto lavorativo per medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale fino al compimento del settantaduesimo anno di età; proroga dello scudo penale per i medici; bonus psicologo; bonus mutui prima casa per under 36; proroga scudo erariale fino al 31 dicembre 2024; ulteriore rinvio multa novax; slittamento taglio dei contributi all’editoria; incremento delle tariffe autostradali del 2,3 %; rinvii che riguardano le assunzioni nell’amministrazione centrale e locale; disposizioni riguardanti il settore scolastico; dotazioni di teaser per la Polizia Municipale.
La ratio alla base della decretazione d’urgenza non sembra essere rispettata dal decreto, che contiene spesso anche proroghe e disposizioni ulteriori rispetto a quelle necessarie per garantire la continuità dell’azione amministrativa e a quelle necessarie per l’efficienza e l’efficacia dell’azione della pubblica amministrazione.
Basti pensare che sui venti articoli del testo originario, sono stati presentati a Montecitorio ben 1218 emendamenti tra maggioranza ed opposizione. I governi Berlusconi hanno senza dubbio sdoganato il Milleproroghe per come lo conosciamo oggi, ma per alcuni l’origine di questo tipo di provvedimenti andrebbe individuata in un altro momento storico. In particolare, in un decreto-legge approvato il 2 gennaio del 1992 dal settimo governo di Giulio Andreotti, composto da 19 articoli piuttosto eterogenei e denominato «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari». Un intervento analogo venne poi fatto nel 1995 dal governo tecnico guidato da Lamberto Dini, anche se
riguardava solo misure d’interesse per i ministeri degli Esteri e della Difesa.
Nel 1996 ci fu però una sentenza molto importante della Corte Costituzionale, che si pronunciò contro la pratica di prolungare la validità dei decreti-legge attraverso proroghe ad hoc, una pratica molto diffusa all’inizio degli anni Novanta. La Corte rilevò che questo stratagemma alterava la natura del decreto-legge, che secondo la Costituzione può essere approvato dal governo solo se ci sono ragioni
di necessità e di urgenza, e deve avere un confine di validità e applicabilità ben definito, anche nel tempo.
La sentenza fece sì che la pratica di fare proroghe ai singoli decreti effettivamente venisse abbandonata. Ma come effetto collaterale indusse i governi a ricorrere sempre più ai cosiddetti decreti omnibus, cioè nei decreti i ministeri inserivano norme più o meno importanti che avevano urgenza di approvare, anche se su materie diversissime l’una dall’altra. Di lì a pochi anni, anche il ricorso al Milleproroghe, cioè a un provvedimento omnibus che prorogava la validità di norme eterogenee, divenne una prassi.
Nella citata pronuncia, la Consulta ha messo in evidenza come “il decreto-legge iterato o reiterato – per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni) il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali – lede la previsione costituzionale sotto più profili: perché altera la natura provvisoria della decretazione d’urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; perché toglie valore al carattere “straordinario” dei requisiti della necessità e dell’urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto; perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il
ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell’ordinamento un’aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d’urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata”. Inoltre, si afferma che “Questa prassi, se diffusa e prolungata, finisce per intaccare
anche la certezza del diritto nei rapporti tra i diversi soggetti, per l’impossibilità di prevedere sia la durata nel tempo delle norme reiterate che l’esito finale del processo di conversione: con conseguenze ancora più gravi quando il decreto reiterato venga a incidere nella sfera dei diritti fondamentali o – come nella specie – nella materia penale o sia, comunque, tale da produrre effetti non più reversibili
nel caso di una mancata conversione finale”.
Più tardi, la Corte Costituzionale ribadì in due occasioni (nel 2012 e nel 2015) che questi decreti devono obbedire a una «ratio unitaria», cioè devono avere la sola funzione di prolungare la scadenza di norme la cui decadenza sarebbe dannosa per il Paese.
Pertanto, in via generale, si evidenzia che sarebbe opportuno sottrarre le norme divenute ormai strutturali dallo strumento annuale del DL Milleproroghe, stabilizzandole definitivamente nell’ordinamento. La continua proroga di tali termini legislativi genera incertezza normativa, alimentando altresì il già frastagliato quadro normativo.
Una ricerca fatta nella letteratura e nelle fonti estere risulta che in nessuno dei principali paesi europei esista un istituto simile al nostro Milleproroghe, per spessore e ripetitività costante nel tempo, sebbene ovviamente non manchino anche negli altri ordinamenti provvedimenti legislativi contenenti alcune proroghe.
L’eterogeneità delle materie contenute all’interno del Milleproroghe potrebbe in qualche modo ricordare gli Omnibus Bill statunitensi, anche se questi ultimi non riguardano esclusivamente la proroga e la deroga di discipline normative. Il più noto tra tutti è infatti l’Omnibus Spending Bill, utilizzato per allocare i fondi federali tra i diversi dipartimenti e agenzie del governo degli Stati Uniti, che però assomiglia più alla nostra legge di bilancio che il Congresso discute e approva con cadenza annuale, ma senza che ci siano proroghe generalizzate. Ma perché abbiamo bisogno del Milleproroghe? Una parte della risposta a questa domanda è già contenuta nell’analisi appena fatta: imprevidenza, scarsa capacità o volontà di analizzare costi, benefici e fattibilità delle norme, distanza fra le declamazioni di principio e la realtà.
Fra le ipotesi avanzate, una delle più interessanti è quella che punta il dito contro l’approssimazione della fase di istruttoria che precede l’approvazione delle leggi (es. una valutazione d’impatto della legislazione condotta in modo adeguato), che costringerebbe sistematicamente il legislatore italiano a rivedere i termini di scadenza di una data disciplina, invece che, come stabilito dall’articolo 79 del Regolamento della Camera dei Deputati, valutare “l’adeguatezza dei termini previsti per l’attuazione” di una normativa.
Un’altra interpretazione della ricorrenza dei Milleproroghe è quella che vede nel sistema legislativo italiano un bisogno ricorrente di “manutenzione legislativa”, ovvero di produzione normativa che non introduce nuove discipline ma ne modifica di precedenti, apportando variazioni spesso di tipo accessorio.
In altre parole, dinanzi ad una legge di riforma, i parlamentari, consapevoli dei problemi applicativi che potrebbero sorgere, ipotizzano la possibilità di una correzione o integrazione del testo legislativo per renderne più agevole l’attuazione. Lo strumento del Milleproroghe servirebbe quindi proprio a gestire,
attraverso proroghe, rinvii e regimi transitori, questa fase di “collaudo” di una determinata disciplina, in modo da consentire al legislatore di valutarne più attentamente la portata.
Un’ipotesi altrettanto interessante è quella che sottolinea l’eccessiva debolezza del Governo e del potere legislativo di fronte alle pressioni esercitate dalle strutture ministeriali e dai vari gruppi d’interesse, in mancanza di un indirizzo politico chiaro e sostenuto.
Nel testo di quest’anno ci sono proroghe che prolungano provvedimenti i cui termini originari sono scaduti da più di cinque anni: norme, dunque, che restano valide solo in virtù del fatto che ogni anno vengono rinnovate all’ultimo minuto con questo genere di decreti. Il comitato per la legislazione della Camera, un organismo che esprime pareri sulla qualità dei provvedimenti in esame nelle varie commissioni, ha contato 19 di questi casi.
Il Milleproroghe costituisce insomma un’anomalia ormai tollerata, seppur criticata.