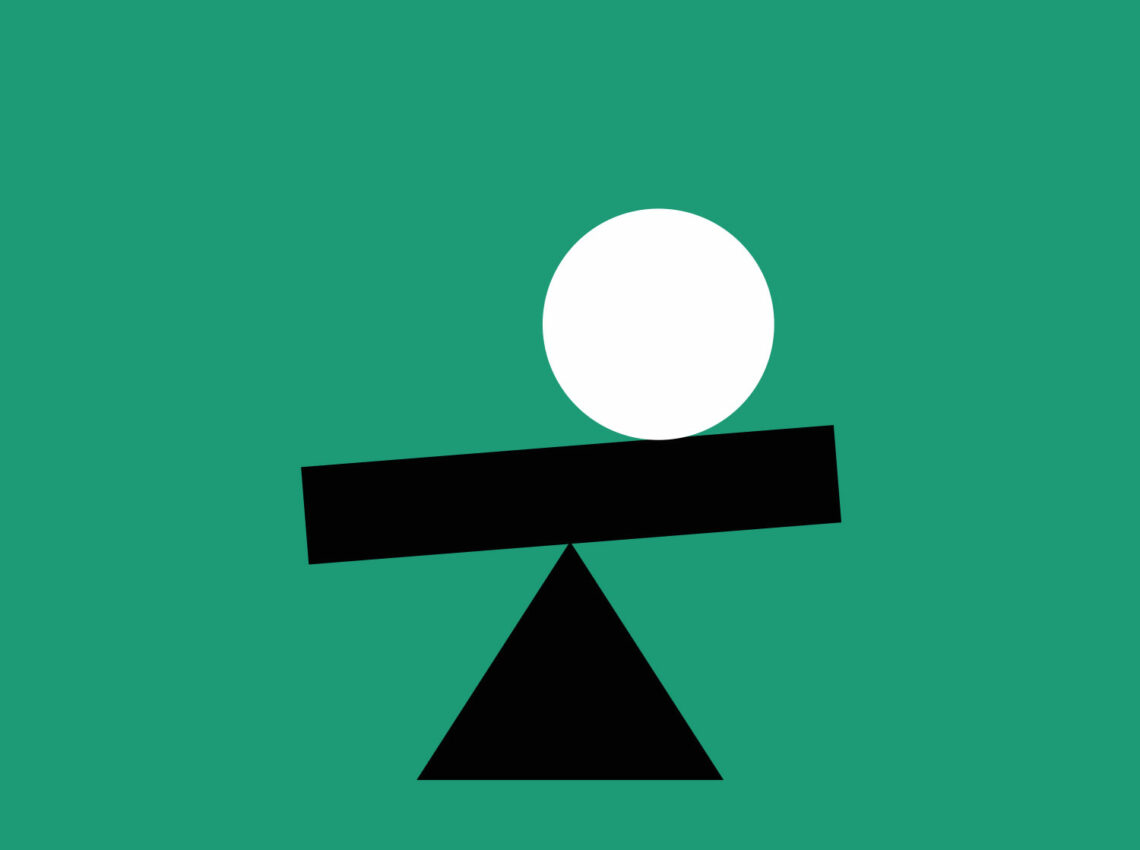UNA LEGISLATURA “DIMEZZATA” MA NON “RINNOVATA”

La drastica riduzione di deputati e senatori derivante dalla legge costituzionale n. 1 del 2020 ha comportato una discontinuità tra la XVIII e la XIX legislatura ancora maggiore di quella che di solito si verifica tra una legislatura e l’altra. Una discontinuità che pare peraltro, almeno finora, più significativa sul piano della diminuzione del personale politico che su quello del mutamento istituzionale.
All’indomani della conferma referendaria, nel settembre 2020, della revisione costituzionale sulla riduzione di deputati e senatori, avvenuta con un risultato schiacciante, a buon titolo ci si sarebbe potuto attendere una decisa ripresa del percorso di modernizzazione dei due rami del Parlamento. Auspicabilmente nella logica dell’armonizzazione e dell’introduzione di maggiori sinergie tra i due rami del Parlamento.
Una logica incoraggiata, per un verso, dalla lettura che la Corte costituzionale (specie nel monitofinaledellasentenzan.35del2017)ha dato del bicameralismo paritario dopo l’esito negativo del referendum costituzionale del 2016 e dalla conseguente omologazione dei sistemi elettorali di Camera e Senato avvenuta con la legge n. 165 del 2017.
E altresì seguita con convinzione nella prassi, per altro verso, per effetto del cosiddetto “monocameralismo alternato”, che ha ridotto a due soltanto le letture non solo dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ma anche di larghissima parte degli altri progetti di legge.
Questo percorso di modernizzazione avrebbe potuto approfittare, oltre che della riduzione dei parlamentari, anche delle opportunità offerte dai processi di digitalizzazione, che a seguito della pandemia del Covid-19 hanno registrato una brusca accelerazione.
Al contrario, il percorso di innovazione dei regolamenti di Camera e Senato si è trascinato piuttosto stancamente, e con approccio prevalentemente “al ribasso”, nelle sedute delle Giunte per il regolamento svoltesi negli ultimi due anni della XVIII legislatura, ed è pervenuto a un esito positivo alla fine del luglio 2022, all’indomani dello scioglimento delle Camere, esclusivamente presso il Senato: al ramo del Parlamento che, invero, già aveva avuto modo di rivedere, anche abbastanza in profondità, le sueregoledifunzionamentonegliultimigiorni della legislatura precedente, nel dicembre 2017.
In un Senato ora formato da 200 senatori elettivi (oltre ai senatori a vita) si è proceduto ad una riduzione a 10 delle commissioni permanenti, ad un abbassamento a 6 senatori (a 9 senatori, se corso della legislatura) della soglia numerica per formare un gruppo parlamentare (con la contestuale introduzione delle componenti politiche del gruppo misto e dei senatori elettivi “non iscritti”), ma anche all’introduzione di un Comitato per la legislazione (in analogia all’organo operante alla Camera dal 1998, seppure con qualche diversità nelle rispettive attribuzioni) e a una nuova disciplina “anti- transfughismo”.
A quest’ultimo proposito, si è dovuto sostanzialmente prendere atto del fallimento della disciplina che era stata dettata meno di cinque anni prima, la quale è stata oggetto di un’interpretazione lasca e mai espressamente giustificata (a partire dalla formazione, nel settembre 2019, del gruppo di “Italia Viva-PSI”).
Il percorso di innovazione dei regolamenti di Camera e Senato si è trascinato piuttosto stranamente, e con un approccio prevalentemente “al ribasso”
Nulla di tutto ciò è successo alla Camera, ove pure si erano registrati (faticosi) tentativi volti a costruire un percorso di riforma regolamentare e persino, nelle parole usate dal Presidente Fico nella seduta della Giunta per il regolamento del 4 marzo 2020, ad avviare una “riflessione complessiva sulle modalità di lavoro degli organi parlamentari e sulle relative procedure”, da svolgere appunto alla luce della riduzione di deputati e senatori. Tentativi però che non hanno trovato un adeguato consenso per giungere a conclusione entro la fine della XVIII legislatura.
Dunque, all’inizio della XIX legislatura, la Camera si è trovata a dover applicare un regolamento rimasto sostanzialmente immutato da oltre un ventennio e per più parti ormai obsoleto.
E si è guardata bene dal ridurre il numero delle commissioni permanenti, forse per paura di rinunciare a qualche posizione di presidente, utile per accontentare deputati di rilievo: per di più, si è dato luogo all’elezione di 14 presidenti di commissione tutti uomini, con una scelta evidentemente per più profili poco difendibile davanti all’opinione pubblica.
Non sarebbe stato impossibile ridurre a 10 il numero delle commissioni permanenti anche in questo ramo del Parlamento, con una minima novella regolamentare, eventualmente prorogando di una o due settimane l’attività della commissione speciale, costituitasi come di consueto per assicurare il tempestivo esame dei disegni di legge di conversione di decreti- legge e degli atti del Governo.
Ad ogni modo, l’effetto sistemico è stato quello di introdurre rilevantissime disparità nella ripartizione delle materie – e dunque nella corrispondente aggregazione degli interessi – tra Camera e Senato: così dando origine, con ogni probabilità, ad asimmetrie che renderanno più arduo il cammino dei progetti di legge, specie laddove non si faccia ricorso alle consuete scorciatoie procedurali, e finiranno per indebolire ulteriormente il ruolo del Parlamento.
Nel medesimo spirito continuista, la Giunta per il regolamento della Camera ha prontamente re-interpretato i requisiti per la costituzione dei gruppi c.d. “in deroga” – requisiti rimasti incredibilmente inalterati nel disposto dell’art. 14, comma 2, del regolamento dal 1971, da ben prima dell’approvazione della legge elettorale maggioritaria del 1993 (il cosiddetto Mattarellum) – in modo da consentire la formazione di gruppi con meno di 20 deputati (e invero anche di 10 deputati, ossia della soglia minima richiesta per formare una componente politica del gruppo misto), anche ove corrispondenti a forze politiche rimaste al di sotto delle soglie di sbarramento (non solo di quella del 3%, ma pure di quella dell’1%).
Una volta formatisi i gruppi (anche quelli “in deroga”) e le 14 commissioni permanenti, alla Camera si è riaperto il cantiere delle riforme regolamentari, delineandosi un intervento in due tappe.
La prima tappa, consistente quasi esclusivamente in una serie di mutamenti di soglie numeriche (e nell’abrogazione di quattro disposizioni desuete), è stata definita dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 23 novembre ed approvata dalla Camera il 30 novembre 2022 (doc. II, n. 5): tra l’altro, con modifiche destinate ad entrare in vigore solo a partire dalla XX legislatura (un inedito assoluto, per modifiche approvate nei primi mesi di una legislatura), si sono ridotte a 14 deputati la soglia ordinaria per costituire un gruppo e a 7 deputati quella per formare una componente politica del gruppo misto, e si è diminuito il numero dei membri della Giunta per le elezioni (20 deputati) e di quelli della Giunta per le autorizzazioni (15 deputati). La seconda tappa, volta invece – per usare le parole del Presidente Fontana nella medesima seduta della Giunta – a dare “maggiore coerenza e razionalità al Regolamento della Camera, specialmente sul versante della disciplina dello svolgimento dei lavori dell’Assemblea”, da realizzarsi più avanti, nel corso della XIX legislatura.
Anche al Senato si è registratza una mini- modifica regolamentare di inizio legislatura, approvata il 1° febbraio 2023: una ennesima disciplina, dichiaratamente transitoria, della composizione del Consiglio di Presidenza, sempre nel tentativo – assai arduo, con un’articolazione in gruppi precaria e ad alta variabilità – di conciliare, in essa, i principi della proporzionalità e della rappresentatività (di tutti i gruppi). Inoltre, la costituzione delle commissioni bicamerali – rimaste sostanzialmente inalterate nel numero – si è realizzata con quasi un anno di ritardo, dovuto alla difficoltà di ripartirsi le relative presidenze tra i gruppi parlamentari: un pessimo, ulteriore segnale dell’incapacità di auto-riforma delle Camere e della sottovalutazione degli strumenti del controllo parlamentare.
Un ritardo cui sta ora facendo seguito una moltiplicazione delle commissioni di inchiesta, originandosi così un evidente sovraccarico soprattutto per i senatori, costretti a districarsi tra una molteplicità di organi collegiali, che tra l’altro tendono a riunirsi spesso in concomitanza, negli interstizi lasciati liberi dall’assemblea.
In definitiva, duole constatare che la finestra di opportunità – e di discontinuità – che si era aperta per effetto della riduzione dei parlamentari non sia stata colta e che Camera e Senato continuino ad agire, in proposito, senza pressoché alcun coordinamento, anziché cercare di muoversi in modo unitario a tutela di un ruolo, quello del Parlamento, già da tempo in declino e che ha subìto ulteriori colpi per effetto delle prassi invalse durante la pandemia.